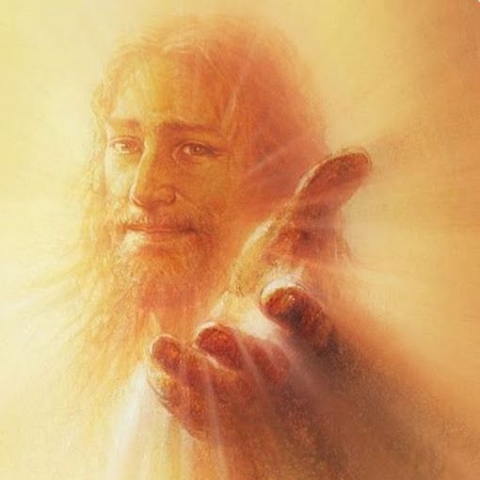La dottrina del peccato originale non è un ingombrante relitto del passato di cui dovremmo liberarci al più presto, come alcuni sostengono. Al contrario, ha molto da insegnare all’uomo contemporaneo, ma bisogna purificarla dagli equivoci e dai fraintendimenti che gravano su di essa. Occorre innanzitutto distinguere tra il dogma, così come è stato ratificato dal Concilio di Trento nel XVI secolo, e il racconto della caduta di Gen 2,4b-3,24. Il racconto in sé è un capolavoro sapienziale che descrive la dinamica del peccato, spiega in modo straordinariamente dettagliato e preciso cosa avviene quando l’uomo cade, ma è stato offuscato e deturpato dal dogma. Paul Ricoeur lo afferma in maniera categorica: «Non si dirà mai abbastanza quanto male ha fatto alla cristianità l’interpretazione letterale, bisognerebbe dire “storicistica”, del mito di Adamo; essa lo ha fatto cadere nella professione di una storia assurda e in speculazioni pseudo razionali sulla trasmissione quasi biologica d’una colpevolezza quasi giuridica per l’errore di un altro uomo, respinto lontano nella notte dei tempi, non si sa bene dove, tra il pitecantropo e l’uomo di Neanderthal. Contemporaneamente il tesoro nascosto del simbolo adamitico è stato sperperato» (P. Ricoeur, Il conflitto delle interpretazioni). L’interpretazione di cui parla Ricoeur imprigiona l’uomo in una condizione paradossale in cui egli è colpevole di tutto – anche di colpe non sue, commesse da ignoti antenati – e non è responsabile di niente: «Dannati senza colpa e redenti senza merito», così Vito Mancuso descrive questa condizione. Un cristianesimo autentico e coerente, al contrario, dovrebbe rendere l’uomo sempre più maturo, adulto e consapevole. È auspicabile che il dogma venga al più presto rivisto e aggiornato, non nella sostanza, certo, ma nella forma, giacché questa – come sostengono Walter Kasper e altri – risente inevitabilmente delle contingenze storiche e culturali in cui è stata espressa.
«CHIUNQUE RIMANE IN LUI NON PECCA» (1GV 3,6)
Il racconto della caduta può essere letto in diversi modi. L’interpretazione classica considera la caduta come ὕβϱις o peccato d’orgoglio: è l’illusione autarchica di vivere nella completa indipendenza da Dio, di diventare arbitri assoluti della propria esistenza. Una seconda interpretazione vede il peccato originale come concupiscenza, cioè come desiderio che non accetta limiti, che vuole tutto e subito. La concupiscenza non riguarda solo la sessualità ma interessa ogni ambito della vita umana; si può cadere nella concupiscenza, per esempio, quando si legge un libro, si scrive un articolo o si parla con un amico e si è presi dalla frenesia di dire tutto, di spiegare ogni cosa. Nella Genesi questa concupiscenza è espressa dal “merismo” bene-male, che rappresenta la totalità del reale: all’uomo non è dato conoscere l’intera realtà, soprattutto se si intende l’espressione nel senso ebraico, come conoscenza unitiva («non conosco uomo»). Notare che la concupiscenza è strettamente legata al problema della scelta: “voglio tutto, prendo tutto” equivale a “non scelgo niente”.
Una terza chiave di lettura – molto mistica, profondamente spirituale – è quella proposta dall’Anonimo autore de La nube della non conoscenza, straordinario trattato di mistica medievale tuttora considerato tra i migliori nel suo genere. L’Anonimo interpreta la caduta come rottura o cessazione dello stato contemplativo. A suo avviso, l’uomo pecca quando smette di contemplare Dio, secondo quanto leggiamo in 1Gv 3,6: «Chiunque rimane in lui non pecca». Prima del peccato tutti gli impulsi della volontà convergevano su Dio. Il peccato originale sarebbe allora una sorta di distrazione della volontà, in seguito alla quale le energie e le facoltà umane si disperdono in mille rivoli. L’uomo non è più padrone degli impulsi della propria volontà e li vede sistematicamente inclinare verso il male. Ciò si manifesta soprattutto nella straordinaria difficoltà di disciplinare l’immaginazione, in quell’incessante chiacchiericcio mentale contro cui il contemplativo deve strenuamente combattere.
Ma c’è una conseguenza ben più nefasta della confusione mentale: allontanandosi da Dio, “disobbedendo” a lui, l’essere umano comincia a sprofondare nella follia. Lo si vede nella risposta insensata che la donna dà al serpente quando questo le domanda se è vero che Dio ha proibito di mangiare i frutti di ogni albero del giardino. No, ribatte la donna: possiamo mangiare di tutti gli alberi, tranne di quello che sta in mezzo al giardino, e anzi non dobbiamo neanche toccarlo, altrimenti moriremo (Gen 3,1-3). Ma in mezzo al giardino non c’è l’albero della conoscenza del bene e del male, del quale non è concesso cogliere il frutto, bensì l’albero della vita (Gen 2,9). Irretita dai ragionamenti capziosi del serpente, la donna commette un errore disastroso: scambia di posto i due alberi del giardino. Nella sua mente si insinua così l’idea che Dio sia colui che si oppone alla vita, che impedisce all’uomo di vivere. È il capovolgimento della realtà, il ribaltamento della gerarchia ontologica tipico del peccato: Dio, che è il sommo bene, diventa male, mentre il male appare come bene desiderabile.
L’ERRORE SECOLARE DELLA CRISTIANITÀ
Se quanto dice l’Anonimo ha un senso, allora il peccato originale sarebbe, più che una colpa morale, una mancanza ontologica, una patologia della relazione, cioè l’incapacità di mantenere l’attenzione focalizzata su quel Dio che, nell’Antico come nel Nuovo Testamento, si presenta come Essere (cfr. Es 3,14; Gv 8,24-58). In effetti un altro grave errore del cristianesimo è l’aver sempre concepito il peccato in termini di trasgressione morale: «Il peccato in realtà esiste nella relazione con Dio e non altrimenti. L’errore secolare della cristianità è stato di concepire il peccato come una colpa morale. […] Il peccato è la rottura con Dio e le conseguenze che ciò comporta», scrive il giurista, sociologo e teologo Jacques Ellul in Anarchia e cristianesimo. Distraendo la volontà dall’Essere, l’uomo si trova frammentato, diviso, alienato da se stesso. Il peccato dissipa, disperde, debilita; la relazione con l’Essere unifica e dà vita. Non a caso Teilhard de Chardin scrive ne Il fenomeno umano: «Già secondo il pensiero greco – anzi secondo ogni pensiero – “essere” ed “essere uno” non è forse la stessa, identica cosa?».
IL TEMPO DEL MITO
Secondo Thomas Merton, il racconto della Genesi afferma che l’Adam è stato creato come contemplativo. La contemplazione è la condizione naturale dell’uomo, e senza di essa non si dà una vita autenticamente umana. Ora la contemplazione – che Merton descrive come «quello stato in cui tutto è tuo ma a una condizione infinitamente importante: che sia tutto dato» - è una situazione meravigliosa ma difficilissima da raggiungere e ancor più da mantenere. Chiunque abbia un minimo di familiarità con la preghiera del silenzio lo sa bene. Basta niente per perdere la pienezza data dalla perfetta contemplazione: un attimo di distrazione, un moto di impazienza o di rabbia, un pensiero impuro, e subito ci si ritrova fuori dal giardino. Ecco perché Kierkegaard, padre dell’esistenzialismo cristiano, afferma che questa è davvero la condizione di ogni essere umano: «Ma la malinconia è un peccato, è veramente un peccato “instar omnium”, poiché è peccato non volere profondamente, e sentitamente; questo è il padre di tutti i peccati» (S. Kierkegaard, Saper scegliere). L’uomo vive costantemente in esilio dal paradiso terrestre. Per questo non ha molto senso, riguardo al peccato originale, parlare di un prima e di un dopo, di una condizione prelapsaria e di una postlapsaria. Il racconto della caduta è un mito e il tempo del mito è “sempre”.
IL MALE DEL MONDO
Negli incontri dell’Associazione Italiana TdC di quest’anno (sezione di Roma), e in particolare in quello di Paolo Trianni sulla spiritualità dell’attraversamento, è risuonata più volte la domanda: “unde malum”, da dove viene il male del mondo, di chi è la colpa? Non si può dare una risposta semplice e univoca perché non c’è “il male” ma ne esistono molti tipi diversi, forse infiniti. Esiste il male naturale, cioè le malattie, gli incidenti, le catastrofi; c’è il male psichico e quello metafisico, il male morale e il male sociale, che il CCC 1869 descrive come “strutture di peccato” che rendono gli uomini complici gli uni degli altri e fanno regnare tra di loro la concupiscenza, la violenza e l'ingiustizia. Lo tsunami che il 26 dicembre 2004 si abbatté su Indonesia, Sri Lanka, Thailandia e India causando oltre 250.000 morti può certamente essere considerato un male, ma è un male molto diverso da quello commesso dal marito che tradisce la moglie, dall’imprenditore che schiavizza i lavoratori o dal folle di Ardea che uccide due fratellini, un pensionato e poi si suicida. Pretendere di spiegare mali così diversi con un’unica causa, il peccato originale, può essere comodo e rassicurante, ma è ingiusto e sbagliato, non è una vera spiegazione. In passato, un certo tipo di cristianesimo vedeva una stretta relazione tra le tante piaghe che affliggono l’umanità, facendo di tutta l’erba un fascio: se l’uomo soffre, si ammala, muore, è perché ha peccato. Oggi non è più possibile sostenere una cosa del genere, come afferma Raimon Panikkar: «La morte è un’invariante umana. Ogni uomo muore, e non certo in conseguenza del peccato. Non c’è nessun peccato originale, e nessuna vendetta di Dio contro il genere umano. Si tratterebbe non di giustizia divina ma di una spaventosa giustizia tribale, diceva Norberto Bobbio» (R. Luise, Raimon Panikkar. Profeta del dopodomani). Una parte considerevole del male che c’è nel mondo non dipende da noi, non è colpa nostra. E men che meno è colpa di Dio, scrive Teilhard de Chardin in Mon Univers (1924): «In sé, in modo immediato, le servitù del Mondo – anzitutto quelle che c’intralciano, ci diminuiscono, ci uccidono – non sono né divine né in alcun modo volute da Dio. Rappresentano la parte d’incompiutezza e di disordine che guasta una creazione non ancora perfettamente unificata. E, in quanto tali, non piacciono a Dio; e Dio, in un primo tempo, lotta con noi (e in noi) contro di esse. Un giorno, Egli ne trionferà. Ma poiché la durata delle nostre esistenze individuali è senza proporzione con la lenta evoluzione del Cristo totale, è inevitabile che non possiamo vedere la vittoria finale, nel corso dei nostri giorni terrestri (…)».
VERA COLPA O IMPERFEZIONE ORIGINARIA?
Un’altra domanda emerge spesso negli incontri dell’associazione TdC: il peccato originale è veramente un peccato così come lo definiscono i dizionari di teologia, cioè una decisione libera e volontaria contro il volere di Dio? O è dovuto piuttosto a un’imperfezione originaria di cui l’uomo non può essere incolpato più di tanto? Anche qui la risposta non è univoca. Se consideriamo l’ateismo delle nostre società secolarizzate come peccato di ὕβϱις, per esempio, la volontarietà è abbastanza evidente: l’uomo sceglie di non credere, vuole essere ateo, anche se forse non si rende conto delle conseguenze che ciò comporta. Ma nel caso della caduta intesa come rottura dello stato di contemplazione? Si tratta certamente di un peccato secondo il significato etimologico del termine, cioè un mancare il bersaglio, un fallimento esistenziale, dovuto però non a volontà quanto piuttosto a una carenza di volontà, oltreché alla difficoltà della contemplazione. La contemplazione richiede vigilanza, attenzione costante, umiltà, dominio di sé. È un esercizio estremamente impegnativo, totalizzante: possiamo davvero incolpare l’uomo se non sempre riesce nell’impresa? L’uomo è realmente colpevole di questo peccato d’origine o ne è vittima? Pecca perché vuole o perché non sa volere? Per risolvere la “vexata quaestio” sarebbe opportuno separare e tenere distinti colpa e peccato, l’aspetto etico-giuridico da quello più propriamente ontologico ed esistenziale: forse l’uomo non ne ha colpa, ma vive certamente in una condizione fallimentare dalla quale può affrancarsi grazie all’azione redentrice del Cristo. Vale pertanto la pena dedicarsi con tutto l’impegno al «nobile lavoro» di cui parla l’Anonimo, cioè alla contemplazione. Questo ci darà la forza per vincere molti peccati personali e per resistere alle ingiurie delle servitù del mondo di cui parla Teilhard in Mon Univers. In attesa che Dio trionfi definitivamente su di esse.