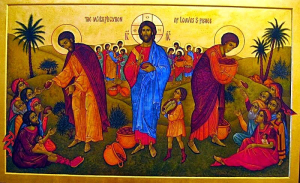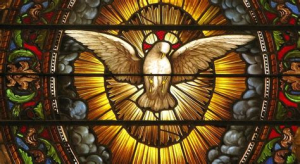Domenica di Pentecoste - Anno C
Omelia di Paolo Scquizzato
Prima Lettura At 2,1-11
Dagli Atti degli Apostoli
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfìlia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».
Salmo Responsoriale Sal 66 (67)
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.
Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.
Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore.
Seconda Lettura Rm 8, 8-17
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani.
Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene.
Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi.
Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché, se vivete secondo la carne, morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio.
E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria.
Sequenza
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sórdido,
bagna ciò che è árido,
sana ciò che sánguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Canto al Vangelo
Alleluia, Alleluia
Vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Alleluia, Alleluia
Vangelo Gv 14, 15-16. 23-26
Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».
OMELIA
«Fare appello allo Spirito Santo vuol dire fare appello alla libertà della coscienza perché la punta alta della coscienza è la punta alta su cui batte il raggio dello Spirito. Per questo lo zelo delle istituzioni è nel coprire tutte le punte perché non appena la coscienza si illumina si scompagina un ordine esistente e il futuro irrompe. Ecco perché le istituzioni sacre hanno perseguitato i profeti; esse li hanno temuti, a cominciare da Gesù» (Ernesto Balducci).
Ogni istituzione, religiosa o laica che sia, ha sempre temuto che le persone agissero
‘secondo coscienza’, prediligendo persone mute, obbedienti ed allineate all’autorità
costituita, zittendo le voci del dissenso, contrarie al ‘è bene così’ o del ‘s’è sempre fatto così’.
Ogni sistema di potere, dai tempi della Torre di Babele ha auspicato che i propri sudditi parlassero tutti la medesima lingua – quella del ‘capo’ – nella speranza che poi agissero anche nel medesimo modo.
Lo Spirito di Dio – insegna Gesù – deve soffiare sempre più forte, dove vuole,
scombinando le carte e facendo sì che ciascuno parli finalmente la propria lingua, e
agisca secondo coscienza.
È interessante notare come nel vangelo Gesù guarisca numerose persone mute. Mi piace pensare che siano state quelle zittite perché non allineate e obbedienti all’establishment di turno. Zittite magari fin da piccoli, da genitori, educatori, superiori perché ritenute non interessanti, banali, fuori luogo, inadeguate, ‘non all’altezza’. Gesù quando parlava con le persone deve aver avuto la meravigliosa capacità di infondere in tutte loro la fiducia di poter aprire finalmente bocca, di convincerle a parlare perché anche loro avevano qualcosa di bello, di interessante e di unico da dire.
Lo Spirito di Dio soffia, sempre, e comunque, indipendente da chi detiene il potere. E
crea unità in un’umanità formata da genti diverse, religioni diverse, esperienze diverse in quanto ciascuno è portatore di verità, di bellezza e fecondità, non fosse altro perché unico e irripetibile.
Il nostro compito di cristiani non è far sì che le varie ‘lingue’ delle donne e degli uomini del nostro tempo riconoscano il primato della nostra di lingua –ritenuta vera e
indefettibile – ma far di tutto perché ogni diversità venga affermata e difesa affinché
un’umanità più umana possa edificarsi, fondata sulla logica della pace, della cura e della condivisione.
Paolo Scquizzato