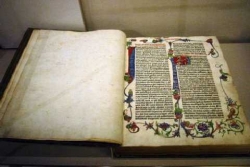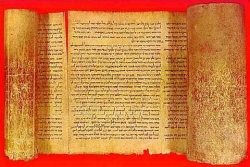Formazione Religiosa
Visualizza articoli per tag: Bibbia, Sacra Scrittura
I due decaloghi nella Bibbia (Olivier Artus)
I due decaloghi nella Bibbia
di Olivier Artus *
Il termine decalogo (dieci parole) designa, nel Pentateuco, due testi legislativi pressoché identici nel contenuto, ma divergenti nel significato e nell’interpretazione teologica delle leggi che vi sono esposte: i versetti da 2 a 17 del capitolo 20 dell’Esodo e i versetti da 6 a 21 del capitolo 5 del Deuteronomio. Questi due testi possono essere letti indipendentemente dal loro contesto, perché costituiscono codici legislativi autonomi. Questa denominazione decalogo può apparire sorprendente perché il numero delle prescrizioni che vi si trovano riunite supera il numero dieci; il termine rimanda ad altre sezioni del Pentateuco che designano come «le 10 parole» il discorso che Dio rivolge a Mosè sulla montagna.
In un primo tempo restituiremo i due decaloghi al loro contesto letterario, poi analizzeremo il loro contenuto sottolineando le differenze che li separano e alla fine preciseremo la funzione di questi due testi legislativi.
Il contesto letterario
Il decalogo del libro dell'Esodo (20,2-17) è collocato nel contesto del racconto della conclusione dell'Alleanza tra Dio ed Israele: il popolo uscito dall'Egitto (Es 14) giunge alla montagna del Sinai (Es 19,1) dopo un cammino attraverso il deserto(Es l5,22-l8,27). Questo testo precede un codice legislativo più esteso, il codice dell'Alleanza (Es 20,22-23,19), che è il più antico codice legislativo del Pentateuco (VIII sec. a.C.), e il racconto della conclusione dell'Alleanza (Es 24,1-11). Mentre il codice dell'Alleanza si presenta sotto la forma di un discorso rivolto da Jahvè agli israeliti at- traverso l'intermediazione di Mosè, il decalogo si presenta come un discorso di Dio, senza destinatario immediato, valido in ogni luogo e in ogni tempo, cosa che gli attribuisce maggiore autorità.
Una lettura corrente del Pentateuco mostra che questo decalogo è il primo testo esclusivamente legislativo che il lettore incontra: questa situazione di anteriorità rispetto agli altri codici legislativi del Pentateuco contribuisce ad accentuare ulteriormente la sua autorità. Sottolineiamo infine la nettissima cesura che lo separa da ciò che precede e che segue: il decalogo dell'Esodo viene in realtà ad interrompere, senza transizione, il racconto della teofania di Jahvè al Sinai: sembra dunque probabile che la sua redazione sia stata interpolata tardivamente in questo racconto. Analogamente, il decalogo del Deuteronomio (5,6-21) è un discorso rivolto da Dio ad Israele. Esso precede gli altri testi legislativi del libro del Deuteronomio, raggruppati nel codice deuteronomico (Dt 12-26): queste due caratteristiche gli conferiscono la medesima autorità del decalogo del capitolo 20 del libro dell'Esodo.
I due decaloghi sono dunque collocati in sezioni molto diverse del Pentateuco: il decalogo del libro dell'Esodo si colloca nel tetrateuco, un insieme letterario la cui composizione è di fonte sacerdotale. cioè appartiene al gruppo dei sacerdoti del Tempio di Gerusalemme, durante il loro esilio in Babilonia (587-538 a.C.), e poi al ritorno dall'esilio.
Il Deuteronomio invece è stato scritto da autori non sacerdotali. Il testo, nella sua forma attuale, data anch'essa al periodo postesilico.
Analisi dei due decaloghi
L'alternanza di comandamenti esposti sotto forma negativa (Tu non...), o sotto una forma positiva, permette di distinguere tre sezioni in ciascuno dei decaloghi. Queste sezioni sono precedute da un'identica introduzione: Jahvè si presenta che ha liberato il popolo d’Israele facendolo uscire dall'Egitto. L'identità di Dio si afferma dunque in storico a favore di Israele.
I sezione: Es 20,3-7 = Dt 5,7-11
L'analisi del testo ebraico fa emergere un gioco di parole che la traduzione italiana può mascherare: il sostantivo «schiavi» (Es 20,2 = Dt 5,6) deriva dalla stessa radice del verbo «servire» (Es 20,5 = Dt 5,9). Così il culto reso agli idoli è presentato come contraddittorio col culto di Jahvè che ha posto fine alla schiavitù di Israele in Egitto: l'idolatria farebbe cadere Israele in una schiavitù. In realtà il culto reso agli idoli è interessato, poiché essi rappresentano degli dèi che appartengono al pantheon dei popoli stranieri, forze della natura divinizzate percepite come minaccia e che bisogna conciliarsi attraverso sacrifici. A questa relazione «commerciale» che imprigiona chi la intraprende, deve sostituirsi il culto di Jahvè che si colloca nell'ambito della gratuità. Ecco perché i decaloghi proibiscono l'uso del nome di Jahvè nei giuramenti: Israele non può servire gli idoli, e non può servirsi del nome di Jahvè. I comandamenti la cui formulazione è negativa contribuiscono in realtà a definire uno spazio di libertà, di gratuità, in cui si allaccia la relazione tra Israele e il suo unico Dio: Jahvè.
II sezione: Es 20,8-12 e Dt 5,12-16
Questa sezione raggruppa i due soli comandamenti «positivi» del Decalogo, che concernono il sabato e il rispetto dei genitori. Queste due prescrizioni hanno in comune di mettere in relazione, nella loro formulazione, l'obbedienza dovuta a Dio e la cura del prossimo. Così, il rispetto del sabato ha motivazioni teologiche, ma anche conseguenze umanitarie: tutta la gente di casa può riposarsi, le stratificazioni sociali che prevalgono tutta la settimana (distinzioni tra padrone e servitore, tra nativi del paese e stranieri) scompaiono: tutti diventano uguali di Fronte a Dio in un medesimo riposo. Il confronto fra i due testi mette alla luce le divergenze e, in particolare, la motivazione teologica del comandamento del sabato: mentre il riposo sabbatico si riferisce, in Es 20,11 , all'attività creatrice di Dio, la sua motivazione si fonda, in Dt 5,15, sull'evocazione della storia della salvezza. La specificità teologica dei due decaloghi è così posta in rilievo: la teologia della creazione (cui fa allusione Es 20,11) è di fonte sacerdotale, mentre il riferimento alla storia della salvezza (Dt 5, 15) può essere attribuito a fonte deuteronomista.
III sezione: Es 20,13-17 e Dt 5,17-21
Le prescrizioni riunite in quest'ultima sezione hanno in comune di riguardare relazioni col prossimo: la loro formulazione negativa non deve nascondere ciò che qui è in gioco. La proibizione di questo o quel comportamento permette di ricavare uno spazio di libertà per il prossimo. L'omicidio, il furto, le false testimonianze sono l'espressione del desiderio, della cupidigia, della violenza che possono fare del prossimo uno schiavo. Così la libertà appare una delle poste maggiori dei due decaloghi, libertà e gratuità nelle relazioni tra Dio e Israele, libertà e gratuità fondate sulla memoria storica della liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Libertà e gratuità non soltanto nelle relazioni tra l'uomo e Dio, ma anche nelle relazioni sociali: nei decaloghi, la relazione con Dio non procede senza la relazione col prossimo. I decaloghi raggruppano dunque prescrizioni che toccano sia il campo del culto sia quello dell'etica sociale in funzione di una medesima prospettiva: la liberazione offerta da Dio al suo popolo.
Perché due decaloghi?
I due decaloghi sono testi la cui composizione, nella loro forma attuale, può essere riferita il Periodo postesilico. Essi attengono a due teologie diverse, sacerdotale in Es 20 e deuteronomista in Dt 5. L'esistenza di questi due decaloghi riflette la diversità delle opzioni teologiche, al momento del ritorno dall'esilio, in Giudea. Solo una minoranza ha conosciuto l'esilio a Babilonia. La politica di libertà religiosa condotta dal sovrano persiano Ciro a partire dal 538, e poi dai suoi successori, permette il ritorno degli esiliati e la ricostruzione del tempio di Gerusalemme (cf Esd 1,2-4; 5,11 -17; 6,3-5). La lettura dei libri di Esdra e Neemia mostra anche come l'autorità persiana conceda un diritto particolare alle sue minoranze religiose (cf Esd 7,14.26). La composizione di questa legislazione propria dei Giudei porta alla formazione del Pentateuco, della Torà. È in questo testo che si esprimono l'identità e la specificità - giuridica e teologica - del popolo d'Israele, ravvisata in modo diverso dai circoli sacerdotali e dai gruppi «laici» deuteronomisti: mentre la fonte sacerdotale fonda l'identità di Israele sul culto celebrato al Tempio di Gerusalemme dai sacerdoti, è nella storia comune del popolo che gli autori deuteronomisti radicano la stia identità. La riflessione degli autori sacerdotali sfocia nella composizione del tetrateuco, mentre gli autori deuteronomisti pervengono alla redazione del Deuteronomio. Questi due insiemi letterari si fusero poi per formare la Torà.
La presenza, nel tetrateuco come nel Deuteronomio, di un medesimo testo legislativo - escluse le poche divergenze che abbiamo sottolineato - contribuisce a rendere manifesta l’unità della Torà, al di là dei diversi approcci teologici che vi si esprimono. Il Decalogo, preambolo legislativo che precede, nel tetrateuco, il codice dell'Alleanza e le leggi sacerdotali e che precede, nel Deuteronomio, il codice deuteronomista, serve a dare lo spirito delle leggi, e a proporne delle chiavi di interpretazione. A questo proposito, si possono avanzare due osservazioni principali:
• In entrambi i testi, Dio è rappresentato come quello che prende l'iniziativa della relazione che lo lega ad Israele, liberando il popolo dalla schiavitù: l'obbedienza alle leggi appare come la risposta che Dio si attende da parte di Israele. Israele è invitato a esprimere la sua fede rispettando le leggi.
• La relazione con Dio e la relazione col prossimo sono inseparabili l'una dall'altra: la dimensione cultuale della relazione con Dio non può essere separata dalla sua dimensione etica. Così, nel momento in cui Israele completa la redazione della Torà, il Decalogo è inserito nel cuore del racconto dell'Alleanza nel libro dell'Esodo, e come preambolo al codice legislativo del Deuteronomio: esso fornisce una chiave comune per interpretare i codici e le leggi così diverse, risalenti ad epoche differenti, che gli fanno seguito. Esso manifesta l'unità del popolo d'Israele, riunito dalla stessa fede nell'unico Jahvè. Esso dice, al ritorno dall'esilio, l'identità del popoìo ebraico costretto a coabitare in Giudea con altre nazioni, a stare accanto ad altre religioni.
* Docente di Pentateuco all’Institut Catholique di Parigi
(da Il mondo della Bibbia n. 51)
Lo straniero nell’Antico Testamento (Paolo De Benedetti)
Lo straniero nell’Antico Testamento
di Paolo De Benedetti

Fra tutti gli insegnamenti biblici, quello sullo straniero è forse il più disatteso. Oggi si «crea» lo straniero quando l’altro non è assimilabile a noi. E lo si crea non per amarlo, ma per odiarlo, non per accoglierlo, come ci insegnano le Scritture, ma per scacciarlo, per spingerlo oltre le frontiere.
«Non opprimerai lo straniero: anche voi conoscete la vita dello straniero, perché siete stati stranieri nel paese d’Egitto» (Es 23,9). Il pensiero e la normativa biblica riguardo al forestiero e allo straniero (chiariremo più avanti la differenza semantica) si compendiano in questo versetto, uno degli innumerevoli che toccano il tema. Ma, prima di illustrarne alcuni, poniamoci una domanda: perché lo straniero? Come nasce lo straniero?
L’incomunicabilità linguistica
La risposta ci porta molto indietro, a un gesto di Dio. Creando un solo uomo, Dio aveva posto una barriera alla possibilità dello straniero e alla delegittimazione del diverso: «Fu creato un solo uomo... perché nessuno dica al suo compagno: Mio padre era più grande di tuo padre» (Mishnà, Sanhedrin 4.5). Ma poi, fu Dio stesso che da questa ideale identità fece emergere il diverso, lo straniero. «Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole» (Gen 11,1). Sono gli uomini della torre di Babele che così motivano il loro progetto: «Facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra» (ivi, 4). Ma Dio non volle che rimanessero un solo popolo con una lingua sola, confuse la loro lingua, e «li disperse di là su tutta la terra» (ivi, 8). Proprio l’incomunicabilità linguistica è il più importante elemento dell’essere straniero (si pensi all’origine del vocabolo greco bàrbaros, cioè balbuziente, in quanto incomprensibile). Ma il mito biblico contiene un insegnamento fondamentale: non pone un centro rispetto a cui essere straniero, tutti sono reciprocamente stranieri, al centro non rimane nessuno: «Essi cessarono di costruire la città» (ivi, 8). Così come l’altro da me è un io di cui io sono l’altro, allo stesso modo lo straniero è uno (individuo, gruppo, popolo) di cui io sono straniero. Si tratta di una reciprocità che, a ben pensarci, fonda l’identità e la responsabilità dell’uomo.
Tutto questo è messo alla prova non solo a livello individuale, ma ancor più a livello sociale, quando una comunità vive sulla propria terra, e quando perciò lo straniero è – proprio etimologicamente – un extracomunitario. La preoccupazione di tutelare lo status dello straniero ha spinto i legislatori biblici a moltiplicare le norme in proposito, tanto che si potrebbe indicare in questo tema una delle linee tecnologiche fondamentali della Bibbia ebraica.
Lo straniero nella tradizione ebraica
Innanzitutto, occorre un’attenzione alla terminologia: in ebraico la nozione di straniero si «incarna» in vari vocaboli, che contengono sfumature diverse o addirittura opposte. Abbiamo così i vocaboli zar, gher, nokrì o nekhar: approssimativamente, potremmo tradurre il primo con «estraneo», il secondo con «straniero residente», il terzo con «forestiero». Zar designa la cosa o la persona con cui non esiste reciprocità di diritti e doveri, per esempio un culto «estraneo», cioè idolatrico, o una persona estranea, come il laico rispetto al sacerdote. Nokhrì o nekhar è sì lo straniero, ma non residente, di passaggio, come il mercante: non è inserito nella società, e quindi non ha i diritti e i doveri relativi; per esempio non vale verso di lui il divieto del prestito ad interesse (cf Dt 23,21), ma anch’egli può prestare ad interesse. Il vocabolo fondamentale è dunque gher, lo straniero residente (solo in tempi più vicini a noi ha assunto il significato di convertito nell’ebraismo). Secondo 2 Cron 2,16, i gherim – plurale di gher – contati nel censimento di Salomone sarebbero stati 153.600 (si veda il fondamentale articolo di Amos Luzzatto, Lo straniero nella tradizione ebraica, «Studi, Fatti, Ricerche», n. 46, 1989).
I rapporti con lo straniero residente non sono regolati da esortazioni morali, non sono affidati al buon cuore, ma fanno parte della halakhà, ossia della «via» prescritta da Dio sul Sinai a Israele come base dell’alleanza. Si tratta di diritti e doveri che costituiscono una sorta di «contratto sociale», di cui potrebbe essere considerato proemio questo testo del Levitico: «Quando un gher dimorerà presso di voi nel vostro paese, non gli farete torto. Il gher dimorante fra di voi lo tratterete come colui che è nato fra di voi; tu l’amerai come te stesso perché anche voi siete stati gherim nel paese d’Egitto. Io non il Signore, vostro Dio» (Lev 19,33-34). È importante sottolineare la conclusione «Io sono il Signore, vostro Dio», perché è il suggello di tutti i grandi precetti sinaitici, vincolanti perché ispirati non da una coscienza etica umana, ma dalla immediata volontà divina.
Diversità e uguaglianza, lontananza e prossimità
Il primo e più importante diritto del gher è l’uguaglianza giuridica: «Ci sarà per voi una sola legge per il gher e per il cittadino del paese» (Lev 24,22). Perciò il gher condivide con l’orfano e la vedova da un lato, con il sacerdote dall’altra – ossia con coloro che non hanno proprietà terriere – alcuni diritti: come la straniera Rut può spigolare e cogliere ciò che cresce all’ «angolo» del campo, e ha parte alle primizie, alle decime e ai frutti dell’anno sabbatico. Può offrire un olocausto allo stesso titolo di un figlio d’Israele (cf Lev 17,8), e ha il diritto-dovere di osservare il sabato e le feste. E qui si apre la tavola dei suoi doveri: come l’ebreo, non deve cibarsi di cibi lievitati a Pasqua, di sangue, forse (ma la cosa è incerta) di animali non uccisi ritualmente. In sostanza, i divieti imposti al gher mirano a includerlo senza discriminazione alcuna nella società: lasciando però a lui la scelta di farsi pienamente ebreo mediante la circoncisione, e potendo così partecipare alla pienezza del culto, compresa la cena pasquale con l’agnello, oppure rimanere un «timorato di Dio», come si dirà molto più tardi, o, in greco, sebòmenos ton theòn. Tra i proseliti più famosi sono da ricordare la dinastia idumea di Erode e quella, sotto Claudio, del re di Adiabene.
Tutto questo mostra come il popolo ebraico abbia sempre rifiutato una concezione etnico-razziale della propria comunità: è simbolico il caso di Davide, genealogicamente discendente dalla moabita Rut (secondo il diritto rabbinico l’ebraicità si trasmette per via matrilineare, e Rut «entra» nell’ebraismo, non «nasce» nell’ebraismo).ma è altrettanto simbolico che i diritti dello straniero siano indipendenti dalla conversione. In fondo, quando il Levitico comanda: «Ama il prossimo tuo come te stesso» (Lev 19,18), non pone condizioni di scelta religiosa; e il gher è prossimo, reá, cioè vicino. Si potrebbe dire perciò dello straniero quello che i maestri dicono di Dio: egli è lontano e vicino, viene da lontano ed è vicino. Questo rapporto con la lontananza che diventa vicina, con lo straniero che diventa prossimo, in realtà è un elemento essenziale della mia identità. Il versetto sopra citato «Ama il prossimo tuo come te stesso», nella esegesi rabbinica offre anche un’altra lettura, alternativa: «Ama il prossimo tuo perché è te stesso».
Del resto, l’identità di straniero è iscritta fin da principio, ben prima della permanenza in Egitto, nell’ebreo. Il primo a essere chiamato «ebreo», Abramo, incontrò Dio diventando straniero: «Il Signore disse ad Abram: “Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò”» (Gen 12,1).
Abramo, o Abram come allora si chiamava, era così straniero da non sapere neppure dove Dio lo avrebbe condotto. E di suo nipote Giacobbe, così si recita nella formula di offerta delle primizie, il cosiddetto «piccolo credo storico»: «Mio padre era un arameo errante, scese in Egitto, vi sette come un gher con poca gente...» (Dt 26,5). E alcuni popoli stranieri escono proprio dalla famiglia patriarcale: gli ismaeliti da Ismaele, gli edomiti da Esaù, gli ammoniti e i moabiti da Lot. Sono genealogie leggendarie, ma che suggeriscono come la diversità, l’alterità non è mai assoluta. E tuttavia – ricordiamo ancora una volta la torre di Babele – è un aspetto del genere umano disegnato da Dio. Scrive il rabbino Riccardo Di Segni: «La strada ebraica della convivenza dei popoli passa attraverso questa coscienza della diversità, dell’impossibilità dell’imposizione e della coercizione, nella presunzione comunque che vi sia uno spirito che parli e chiami tutti, ciascuno nella sua strada...La particolarità non è ostacolo all’universalità» (L’ebreo: straniero e residente, «Rocca», 15 ottobre – 1° novembre 1986).
Un insegnamento alto e disatteso
Forse, tra tutti gli insegnamenti della Bibbia, questo sullo straniero è oggi il più disatteso: non solo, ma oggi si crea lo straniero appena l’altro non è assimilabile a me, a noi, e lo si crea non per amarlo, ma per odiarlo e se è possibile per scacciarlo. Come accade a Dio, a cui un grande maestro chassidico, rabbi Parukh, riferiva le parole del salmo 119,19: «io sono straniero sulla terra».
Diceva rabbi Parukh: «Chi è sbattuto lontano in terre straniere e finisce in un paese sconosciuto, costui non ha commercio con alcun uomo e non può intrattenersi con alcuno. Ma se allora appare un altro forestiero, anche se la sua patria è un’altra, i due possono diventare amici... E se non fossero stati ambedue stranieri non sarebbero diventati così intimi. Questo intende il salmista: “Tu sei come straniero sulla terra e non hai dove posarti: dunque non sottrarti a me, ma svelami i tuoi comandamenti, perché io possa diventare il tuo amico”» (M. Buber, I racconti dei Hassidim, Guanda, Parma 1992, p.57).
E, aggiungiamo noi, perché io possa riconoscere lo straniero che è in me.
3. Ispirazione della Bibbia (Rinaldo Fabris)
Dio mediante il suo Spirito interviene nell'intero processo di produzione di un testo biblico perché in esso si incarni la verità che egli vuole comunicare agli esseri umani per la loro salvezza.
2. Come è sorta la Bibbia (Rinaldo Fabris)
La formazione dei libri che formano la Bibbia è avvenuta lungo il corso di un millennio prima dell'era cristiana per l'AT e nel primo secolo d.C. per il NT.
Babilonia, figura del Male nell’apocalittica (Michel Trimaille)
Babilonia,
figura del Male nell’apocalittica
di Michel Trimaille *

* Institut Catholique di Parigi
Le imprecazioni dei profeti contro Babilonia sono niente in confronto allo scatenamento dell'Apocalisse di Giovanni. In che modo, sei secoli dopo l'esilio, questa lontana capitale è diventata, per un autore cristiano, il simbolo di tutti gli abomini? Perché «la grande prostituta», quella in cui «si è trovato il sangue dei profeti e dei santi e di tutti coloro che furono uccisi sulla terra», porta il nome di Babilonia?
«Vi saluta la comunità che è stata eletta come vostra dimora a Babilonia, e anche Marco, mio figlio». Strano saluto quello finale di questa lettera apostolica (1 Pietro 5,13)! Si è invano cercato la città che risponde alle informazioni qui date: una Babilonia che avrebbe avuto una comunità cristiana, dove avrebbero verosimilmente potuto soggiornare Pietro e Marco. Si è pensato a un certo campo militare in Egitto, o ancora alla Babilonia di Mesopotamia che, nel secolo della nostra èra, ospitava ancora un'importante colonia giudaica.
Questa ricerca era motivata da un'esigenza di storicità: attribuire alla lettera di Pietro una data che salvaguardasse la sua rigorosa autenticità petrina. Ma si è proprio dovuto cercare altrove la soluzione: noi avevamo lì uno pseudonimo di Roma.
Il nome cifrato di Roma nei testi giudaici
In effetti, Babilonia è il nomo cifrato che i Giudei hanno affibbiato a Roma, ma lo hanno fatto solo in seguito agli avvenimenti del 70, dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme e della nazione giudaica.
Il Quarto libro di Esdra risponde all'angoscia di una comunità giudaica scossa dagli avvenimenti del 70. L'autore pensa che gli avvenimenti del 70 ne siano il «prototipo», cioè che la caduta di Gerusalemme sotto gli assalti di Babilonia sia stata il simbolo delle altre conquiste della città; «Ma gli abitanti di Gerusalemme peccarono... Allora consegnerai la città nelle mani dei tuoi nemici. E ora io ti dico nel mio cuore: si comportarono meglio gli abitanti di Babilonia? È per questo che Babilonia domina Sion?» (III, 25.27.28).
L’Apocalisse siriaca di Baruk, scritta forse una quindicina d'anni dopo la caduta di Gerusalemme, s'interroga sulle cause della disgrazia dei giusti e annuncia loro una vendetta su Roma: «Ma dico questo, io, Baruk, contro di te, Babilonia! Se tu fossi nella prosperità e Sion rimanesse nella sua gloria, sarebbe stato per noi un grande dolore che tu fossi uguale a Sion, ma ora il dolore è infinito, in gemito è incommensurabile, perché tu sei prospera e Sion desolata! Chi sarà il Giudice di tutto questo?... Oh, Signore, come hai potuto sopportare questo?» (XI, 1,2.). «E anche il re di Babilonia che ha ora distrutto Sion... sì giustificherà per il popolo e dirà nel suo cuore cose grandi davanti all'Altissimo, ma lui pure cadrà alla fine!» (LXVII, 7,8).
Gli Oracoli Sibillini, attribuiti alla Sibilla, molto noti in ambiente popolare, riportano sugli avvenimenti dell'ultimo terzo del I secolo, «Dopo quattro anni [dalla morte di Nerone]… una grande stella si abbatterà sul mare divino; essa consumerà il mare profondo, Babilonia stessa, e la terra italiana, a causa della quale sono periti molti ebrei santi e fedeli e il popolo di verità... Tu non sarai che desolazione per moltissimi anni.. O perversa città, effeminata e ingiusta! Disgrazia a te, impura città della terra latina…!» (V, 156, 158-161, 163, 167).
La grande prostituta dell'Apocalisse di Giovanni
La Prima Lettera di Pietro, citata all’inizio, non proferisce minacce contro «Babilonia». Invece, come la maggior parte dei testi giudaici di quest'epoca, l'Apocalisse di Giovanni vede in questo soprannome dato a Roma un pegno di giudizio che si abbatterà su di essa come sulla sua sorella maggiore di Mesopotamia.
Dal 14,8 l'autore annuncia la caduta di Babilonia, la grande, quella che ha abbeverato tutte le genti con il vino del furore della sua fornicazione». Più avanti si legge una lunga evocazione poetica, ispirata ai profeti, della caduta di questa nuova Babilonia (l7,1-9,10). Ma l'autore cristiano non le attribuisce la distruzione del Tempio di Gerusalemme e della nazione giudaica; le rimprovera soprattutto di aver perseguitato i cristiani e di aver decimato la Chiesa. «In essa [Babilonia] fu trovato il sangue dei profeti, dei santi e di tutti coloro che furono uccisi sulla terra» (18,24). L'allusione a Roma è chiara: la città è personificata sotto i tratti di una prostituta seduta su una bestia a sette teste, che sono sette colline, e l'allusione a un «re che era e non è più, e che sarà l'ottava di una serie di sette» (cf 17,10-11), rimanda probabilmente a Nerone e alle credenze popolari che speravano nel suo ritorno. Il carattere cristiano di questa rilettura appare soprattutto nell'opposizione radicale stabilita dall'Apocalisse tra la città distrutta e la Chiesa futura, altra figura femminile, ma sposa dell'Agnello, la cui venuta costituisce il vertice dell'opera.
Las caduta della città impura prima delle nozze dell'agnello
Le due descrizioni cominciano allo stesso modo, con l'invito che un angelo fa al veggente: «Ti farò vedere la condanna della grande prostituta...», «Ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell'Agnello» (17,1-3 e 21,9-l0). E terminano con lo stesso gioco di scena tra il veggente e l'angelo interprete (19,9-10 e 22,6-9). La grande prostituta, vestita di rosso,seduta su una bestia, è anch'essa bestiale: ha ricevuto il suo potere dalla Bestia che lo ha ricevuto dal drago demoniaco (12-13). La città che essa rappresenta è un covo di abomini; sarà distrutta come Sodoma, e non ci sarà più vita in essa (19,21-22). Si vedrà da lontano il fumo degli incendi, poi tenebre totali! Se la sua distruzione provoca i lamenti di coloro che si erano arricchiti al suo servizio e nei traffici di cui essa era il perno al contrario, ciò suscita nel cielo gioia e allegrezza (18,19.20). Infatti, la sua caduta annuncia e prepara le nozze finali dell'Agnello. La sposa di questo Agnello non ha nessun tratto di prostituta: è tutta santa e rivestita della gloria da Dio.
La Gerusalemme celeste: l'antitesi di Babilonia
La città che essa rappresenta è perfetta nella sua architettura, senza alcun abominio, poiché «non entrerà in essa nulla d'impuro, né chi commette abominio o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello» (21,27). Le nazioni cammineranno alla sua luce, che è la luce stessa di Dio: allora «non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà» (22,5). Questa città è attraversata da un fiume di vita, che nutre un albero della vita che produce frutti tutti i mesi dell'anno, «E non vi sarà più maledizione, perché in lei sta «il trono di Dio e dell'Agnello» (22,3).
Se la metafora di Babilonia è così rimasta viva, non solo presso i Giudei, ma anche presso i cristiani, è perché la sorte finale di Babilonia aveva un significato nella loro memoria: era direttamente quello di conservare, nei credenti toccati dalla prosa, una speranza in giorni più felici.
(da Il mondo della Bibbia n. 20)
L’enfant terrible del cristianesimo (Daniel Marguerat)
L’enfant terrible del cristianesimo
di Daniel Marguerat *

In un recente, illuminante libretto, Daniel Marguerat ritorna sulla modernità di Paolo, l’enfant terrible del cristianesimo. Spirito dottrinario, tono ruvido, antifemminismo… non avrebbe sviato il puro messaggio di amore di Gesù in una opprimente dottrina del peccato? Già durante la sua vita, questo rinnegamento del giudaismo irritava. Oggi, molti cristiani lo hanno accantonato, e credono senza Paolo o malgrado lui. Chi legge ancora la corrispondenza di questo apostolo poco amato? Chi coglie l’importanza della "giustificazione secondo fede" o della "salvezza al di fuori delle opere della Legge"? Tuttavia, senza di lui, senza il suo genio a formulare le verità essenziali del cristianesimo, la cristianità sarebbe rimasta un’oscure setta. Senza di lui, duemila anni fa, il messaggio di Cristo non avrebbe infiammato il mondo intero. Se si vuole comprendere la rivoluzione che ha rappresentato nel I secolo lo slancio della fede cristiana, non si può evitare di leggere, e di voler comprendere, questo gigante definito talora il "fondatore del cristianesimo". Non senza fondamento: egli fu, più di chiunque altro, fondatore di comunità.
* Professore di Nuovo Testamento
Facoltà di Teologia, Università di Losanna
Tra Saulo di Tarso (il suo nome aramaico) e Gesù di Nazareth vi è ben poco in comune. Come spiegare allora che l'uno è stato preso per l’altro? Gesù è un ebreo della campagna palestinese, di professione falegname, figlio del popolo e amico di peccatori. Il suo messaggio si rivolge agli uomini e alle donne di Israele. Il suo ministero si è limitato alla Galilea, con un breve sprazzo finale a Gerusalemme. Saulo è un intellettuale della diaspora, nato a Tarso vicino ad Antiochia. Uomo di città e di cultura. Il suo impegno netto nel movimento farisaico lo ha introdotto nell'èlite religiosa del giudaismo del tempo. Forse fu allievo del grande rabbi Gamaliele (At 22,3). Ad ogni modo, la sua formazione all'esegesi rabbinica fu quella di un allievo brillante, capace di maneggiare la Scrittura secondo le regole dei maestri. La pratica del gezera shava, consistente nell'accostare due citazioni per interpretare l'una grazie all'altra, non ha per lui segreti (esempio: Gal 3,l0 e 12). Anche sostenere una parola della Torà con una citazione dei profeti è altrettanto comune in lui come nei rabbini della miglior tradizione. D'altra parte, le più recenti ricerche sul suo modo di condurre l'argomentazione mostrano che l’apostolo delle Genti è esperto nella pratica della retorica greco-romana, alla pari di un Cicerone o di un Quintiliano. Nulla di sorprendente, se si sa che la città di Tarso ospitava un'apprezzata scuola stoica: il padre di Paolo si fece un punto d'onore di mandarvi il figlio. Attraverso l’apprendimento della retorica passava una cultura raffinata.

Le sottigliezze di una doppia cultura
Queste due componenti della cultura di Paolo di Tarso spiegano la difficoltà di comprenderlo oggi; il suo stile, la sua logica, sono quelli di un uomo che suona costantemente su due tastiere: lo stile figurato, analogico del rabbi, e l'argomentazione lineare del retore romano (con introduzione, tesi, dimostrazione e perorazione). L'estrema difficoltà, per gli esegeti, consiste proprio nel tenere collegate le due modalità della sua riflessione, senza farle pendere completamente dal lato della sottigliezza rabbinica o dal lato del rigore dialettico. Ma il confronto con Gesù di Nazaret ripropone il problema: come capire che Paolo, l'intellettuale fariseo di alto livello, sia stato conquistato dal destino dell'uomo di Nazaret? La risposta va cercata nel folgorante sconvolgimento che è la "conversione" di Paolo sulla strada di Damasco. La si fa risalire all’incirca all'anno 32, cioè due anni dopo la morte di Gesù. La fede cristiana, Paolo non l'ha scoperta al suo tavolo di lavoro. Neppure nella profondità della meditazione. All'interno della sua pratica, all'interno della sua militanza, Paolo è stato fermato da Dio. Bloccato nel suo slancio. Ma che cosa è accaduto sulla via di Damasco perché Paolo ne esca stordito, demolito, smarrito? L'uomo si manterrà sempre riservato su questo punto. Quel che certo, è che, un giorno, le basi su cui aveva costruito la sua vita gli sono improvvisamente venute meno. Ne resta traccia in un passaggio autobiografico della lettera ai Filippesi. Paolo inizia elencando il suo impressionante albero genealogico-religioso: "circonciso l’ottavo giorno, della stirpe d'Israele, della tribù di Beniamino, ebreo da Ebrei, fariseo quanto alla legge; quanto a zelo, persecutore della Chiesa: irreprensibile quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge (Fil 3,5-6). Non si potrebbe pretendere maggiore garanzia di appartenenza ebraica! L'eccellenza dell’uomo di Tarso in materia di pietà legale gli permetteva di definirsi, con fierezza, "irreprensibile". Questo forte radicamento nella Torà lo aveva condotto, con tutta la tradizione farisaica, a rifiutare qualunque credito alla fede cristiana in un Messia crocifisso. Che il Dio onnipotente avesse qualche cosa in comune con il corpo di Gesù appeso al legno della croce non poteva essere che una ridicola superstizione, pericolosa e sovversiva. "L'appeso è una maledizione di Dio": questa frase del Deuteronomio (21,23) era citata come un anatema contro questi eretici. Si può confondere la grandezza divina con la fine miserabile di un Galileo, giudicato e condannato come blasfemo? È questo il motivo per cui, nella sua logica estremistica (la sua personalità lo porta a questo), Paolo si era ripromesso di difendere l'onore di Dio punendo quelli che iniziavano ad essere chiamati "cristiani". (Gal 1,13).

Fallimento della religione
Damasco è la scoperta di un fallimento. Non lo scacco di un uomo che non sarebbe stato capace di adempiere ai precetti della Torà. Al contrario: "irreprensibile quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge" (Fil 3,6). È lo scacco della Legge o, più esattamente, lo scacco della fede nella Legge che si presenta a Paolo come una folgorazione. Ecco dove conduce la Torà: a mettere in croce il Messia. Damasco è questo volgersi dello sguardo di Paolo sulla croce, che lo porta a capire come, al culmine dell'impegno per Dio, al culmine della pietà, l'uomo costruisca una croce per il Figlio. Paolo non determina lo scacco del giudaismo, come se altre credenze potessero meglio cogliere il mistero di Dio. Riflettendo su questo problema all'inizio della lettera ai Romani (1,18-3,20), Paolo giunge alla conclusione che "l'ebreo come il greco" falliscono nel loro tentativo di conoscere Dio. Paolo segna lo scacco di ogni religione. Non, una volta di più, attraverso il raziocinio, ma per averlo vissuto nella sua personale esperienza di vita. Ogni religione fallisce nel momento in cui fa nascere nell'uomo l'illusione di poter costruire il proprio valore davanti a Dio. Che si tratti di ammansire Dio attraverso l'osservanza della Torà (l'indagine dell'ebreo) o che si tratti di avvicinarsi a Dio attraverso la ricerca della sapienza (l'indagine del greco), l'errore è lo stesso: in entrambi i casi la pietà diventa un modo di catturare il divino per accattivarselo (I Cor 1,18-25). È il motivo per cui, dirà Paolo ai Corinzi, Dio ha scelto di salvare gli uomini attraverso il messaggio insensato, risibile, della croce: "E mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani" (1,22-23).
Alla sconfitta della religione che tenta di catturare Dio, Paolo oppone la pura gratuità della grazia.

Dio di tutti e di ciascuno
Non si comprende nulla del pensiero di Paolo se non si coglie a quale punto la sua immagine di Dio si è trovata proiettata: lo scorge all’opera nella sua fragilità. Lo credeva tirannico, lo scopre solidale. Lo pensava lontano, ed eccolo presente in ogni sofferenza. Dio non si lascia scoprire che da parte di coloro che abbandonano l'immagine del dio tirannico e si lasciano "giustificare", cioè accogliere, sulla sola base della loro fede in Lui.
Con Paolo inizia questa scoperta, immensa nella storia dell'umanità, del valore di tutti e di ciascuno. Che ogni uomo riceva da Dio un valore insostituibile, nessuno l'aveva affermato con altrettanta forza. Che l'essere umano abbia un valore che non dipende né dalla sua età, né dal suo sesso, né dal suo denaro, né dalla sua pietà, né dal suo ruolo nella società. Che ogni essere sia apprezzato da Dio indipendentemente dalla sua morale o dalle sue (buone) intenzioni, ecco la convinzione che brucia nel centro della teologia di Paolo. E, nelle categorie farisaiche della retribuzione, Paolo dirà: Dio giustifica ognuno senza badare alla sua osservanza della Legge. Egli concede la vita all'uomo "senza le opere della Legge" (Rm 3,21-28).
Di questa idea si alimenterà un concetto che segnerà profondamente l'Occidente cristiano; il concetto di individuo. Sotto l'influsso del pensiero paolino, l’umanità accoglie questa idea che l'individuo, sono qualsiasi latitudine viva, ha lo stesso valore. La Rivoluzione francese aggiungerà: deve godere degli stessi diritti.

Un problema di libertà
La doppia cultura di Saulo di Tarso (greco-romana ed ebraica) gli permette sintesi folgoranti, di cui la cristianità si alimenterà per crescere. La sconfitta della religione è una prima sintesi. L’approccio paolino al problema della libertà ne è un'altra. Gli stoici (ad esempio Epitteto o Seneca) ponevano con insistenza la questione della libertà umana. L'uomo è libero nelle sue scelte? Governa la propria vita? Alla constatazione negativa, gli stoici aggiungevano una risposta: dominare le passioni permette all'uomo di avvicinarsi alla libertà. Paolo riprende la questione, ma la sua constatazione è più radicale: non solo l'uomo non è libero, ma non è in grado di riconquistare la sua libertà attraverso un progetto di autocontrollo. Il peccato - nessuno nel Nuovo Testamento penserà il peccato con maggiore profondità di Paolo - aliena l'uomo e lo scaglia contro Dio. La sola via d'uscita per l'essere umano è di essere liberato dal di fuori, dal momento che non può farlo da solo. Il cap. 8 della Lettera ai Romani descrive questo lavorio dello Spirito nel credente, che, liberandolo dalla costrizione di costruire la sua propria salvezza, lo libera dalla preoccupazione di sé e lo apre alla cura di un altro.

Distruttore della Legge?
Rifiutando la Legge come via di salvezza, Paolo si è attirato l'incomprensione e la collera dei suoi antichi correligionari. Malgrado i suoi dinieghi ("la Legge è santa e santo e giusto e buono è il comandamento", Rm 7,12), l'apostolo delle Genti non si libererà mai dal sospetto di essere un trasgressore della Legge. All'intento del nascente cristianesimo, questo punto costituisce una grande divergenza tra Paolo e il giudeo-cristianesimo di Gerusalemme dominato dalla figura di Giacomo, fratello del Signore. In realtà, se Paolo nega alla Torà la capacità di essere strumento di salvezza (ormai conta solo la fede), Paolo non rifiuta la Legge quando si tratta di segnalare la fedeltà di vita cui sono chiamati i credenti. Arriva anche a dire che "la giustizia della Legge si compie in noi, che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito" (Rm 8,4). In pratica, il credente, non più preoccupato per sé, può aprirsi all'amore dell'altro, cosa che costituisce - per Paolo come per Gesù - il centro della Legge.
Se il rimprovero di distruggere la Legge non è giustificato per quanto riguarda Paolo, il suo discorso sul fallimento della religione (compresa quella ebraica) poneva l'apostolo davanti ad una via senza uscita: Dio, dando già da millenni, la Legge ad Israele, avrebbe sbagliato?

Perché il giudaismo?
La storia del popolo eletto sarebbe stata una storia inutile? Nei capp. 9-11 della Lettera ai Romani di Paolo, costretto ad affrontare la questione, propone una riflessione fondamentale sul destino di Israele. Essa rimane essenziale su quello che noi potremmo (e dovremmo) pensare oggi delle relazioni tra cristianesimo e giudaismo. La formula della salvezza offerta a "chiunque crede" fonda in realtà l'universalità della grazia, ma, contemporaneamente, sottrae ogni consistenza alla particolarità di Israele. Se il cristianesimo è la religione del Dio universale, perché il giudaismo? Seguiamo da vicino le argomentazioni di Rm 9-11. Paolo comincia col constatare il rifiuto opposto da Israele al Messia: gli ebrei non vogliono il Cristo (Rm 9), La parola di Dio è sconfitta? No, Dio indurisce chi vuole, dice Paolo, ed apre il cuore a chi vuole. Questo non impedisce, continua Paolo (Rm 10), che la maggioranza degli ebrei si sia chiusa alla parola del Vangelo. Essi hanno sentito la notizia, ma non vi hanno creduto. Dio avrebbe dunque rifiutato il suo popolo? Il semplice enunciato della questione fa sobbalzare Paolo (Rm 11): assolutamente no! In realtà, la storia di questo popolo ha sempre conosciuto l’indurimento della maggioranza e la fedeltà di un piccolo resto. I cristiani non ebrei corrispondono oggi a questa logica del piccolo resto: essi credono, mentre la maggior parte di Israele rifiuta.

L'enunciato di un mistero
Giunto a questo punto, Paolo sfiora la contraddizione: da un lato Israele è colpevole di chiudersi al Vangelo; dall'altra, fede e indurimento del cuore sono opera di Dio. A quale conclusione arrivare? Da questa scomoda posizione, l'apostolo fa la professione di un mistero: "Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, questo mistero, perché non siate presuntuosi: l'indurimento di una parte di Israele è in atto fino a che non saranno entrate tutte le genti. Allora tutto Israele sarà salvato" (Rm 11,25-26).
Conclusione sbalorditiva! Al pericolo di cadere in contraddizione, Paolo sfugge enunciando un mistero teologico, cioè di una verità che non è data come la conclusione di un ragionamento, ma come una rivelazione. Il suo contenuto è chiaro: alla fine dei tempi, Israele sarà salvato. In altri termini Paolo ammette Israele ai beneficio della giustificazione per fede (quello stesso messaggio che Israele rifiuta). Se è vero che Dio salva per grazia, e senza tenere una contabilità degli sforzi dell'uomo per soddisfarlo, allora non terrà conto del rifiuto che Israele oppone al Messia. La grazia vale anche per il popolo eletto. Attraverso questo mistero, Paolo perviene a rendere giustizia da un lato alla scelta della maggioranza degli ebrei, che rompe col Cristianesimo e non vuole questo Messia. Egli prende dall'altro in considerazione la fedeltà di Dio alle sue promesse: Dio non rinnega la sua parola, nè i suoi. L'apostolo lascia così aperto l'avvenire di Israele, come una storia che deve compiersi tra Dio e il suo popolo eletto, e non riguarda che loro due. Se i cristiani hanno ragione di considerarsi beneficiari della grazia, il destino del popolo ebraico non li riguarda. Questo destino appartiene, giustamente, ad un mistero che si è già avviato tra Abramo e Dio. A questa inviolabile tenerezza di Dio per Israele, nessuno potrebbe attentare. Ma questo dovuto annullamento davanti alla grazia sovrana di Dio non significa per Paolo essere ridotto al silenzio: nel corso della sua intera corrispondenza, egli non cesserà di testimoniare che un dialogo esigente e serrato con il giudaismo è indispensabile alla ricerca della propria identità da parte del cristianesimo.
(da Il mondo della Bibbia n. 53)
Verità della Bibbia (Gaetano Castello)
Verità della Bibbia
di Gaetano Castello
Molte volte il credente, leggendo alcune pagine della Sacra Scrittura, si trova di fronte a problemi di coerenza apparentemente insolubili tanto da determinare in alcuni la scelta di un'adesione piena a ciò che si legge, in altri la scelta di una definitiva «emancipazione» che relega la Bibbia tra i libri di credenze ormai passate e insostenibili.
Verità delle scienze e verità della Bibbia
Le acquisizioni scientifiche moderne, in ogni campo del sapere, rivelano infatti l'incongruenza tra alcuni passi della Bibbia e le posizioni della scienza. Come sostenere che la creazione e il frutto a dell'attività divina descritta nei primi capitoli della Genesi? In Gn 1 si parla della creazione dell'universo e dell'uomo in sei giorni, mentre la scienza parla di intere epoche, di milioni di anni di gestazione per ogni trasformazione, verificatasi nel cosmo, dalla sua origine all'apparizione dell'uomo, recentissima se misurata in termini di milioni di anni. E come si potrà sostenere la creazione dell'uomo come trasformazione di un po' di fango attraverso un soffio divino di fronte alla fondata, benché discussa, teoria dell'evoluzione delle specie?
Domande sulla coerenza della Bibbia con la verità oggettiva dei fatti vanno oltre l'ambito delle scienze naturali coinvolgendo questioni storiche e conoscenze geografiche. Non solo. Alcune domande nascevano anche tra gli antichi lettori della Bibbia che si imbattevano in discordanze interne alla stessa Bibbia, talvolta interne alla stessa narrazione, come è il caso del «diluvio universale» di Gn 6-9.
Eppure la fiducia nella Bibbia come Parola ispirata da Dio stesso quindi «inerrante», come si usava dire fino a prima del Concilio vaticano II, non è mai crollata. In ogni tempo si è cercato di spiegare le incongruenze di cui si è detto proponendo diverse soluzioni. Così gli antichi rabbini sostenevano che le cose sarebbero risultate chiare, alle menti incapaci di comprendere, con il ritorno di Elia che avrebbe spiegato le apparenti discordanze (per es. quelle tra Ezechiele e la Torà). I Padri della Chiesa e gli antichi scrittori cristiani sottolinearono spesso l'aspetto di «mistero» intrinseco alla Parola di Dio, che la rendeva solo apparentemente incongruente. Spesso si indicò la soluzione nella lettura «allegorica» della Bibbia, sottolineando il fatto che le notizie, la descrizione di fatti, avevano in realtà come vero scopo la rivelazione di una realtà superiore, spirituale, di fronte alla quale la coerenza della historia o della littera biblica diventava del tutto secondaria. Benché questo principio della «lettura spirituale» della Bibbia abbia dominato nell'antichità cristiana e nel Medio Evo, l'esigenza di risposte più precise e soddisfacenti ai problemi che nascevano dal confronto tra Sacra Scrittura e scienza divenne sempre più pressante fino a determinare una vera e propria crisi allorché, con l'era moderna, si verificò quel progresso di conoscenza che determinò il superamento dell'antica, unificata concezione dell'uomo e del cosmo.
Il caso più noto, emblematico di questa crisi, è quello di Galileo Galilei con il problema dell'eliocentrismo. L'antica concezione tolemaica veniva minata e con essa la base su cui alcune affermazioni bibliche potevano essere spiegate. Che senso avrebbe avuto a quel punto il comando di Giosuè «fermati o sole» (Gs 10,12-14), se la scienza poteva dimostrare che a girare era la terra e non il sole? Emergeva con drammaticità il problema che avrebbe dominato la coscienza dell'uomo moderno: proseguire nel cammino scientifico con la forza della ragione avrebbe voluto dire abbandonare le antiche concezioni sull'uomo e sul mondo di cui tanti riflessi appaiono anche nella Bibbia? Già sant' Agostino aveva affermato che il Signore «voleva fare dei cristiani, non degli scienziati», una affermazione che sarà ripresa e sviluppata da Galilei nella sua Lettera a Cristina di Lorena del 1615.
Il cammino, come è facile immaginare, non è stato facile. La condanna di Galileo da parte della Chiesa sembrava sancire la rottura tra scienza e fede, tra verità scientifica e verità della Bibbia come qualcosa di inevitabile. La verità, almeno così sembrava ai più, doveva essere ricercata e trovata scegliendo l'una o l'altra via: la fede, con la Bibbia «inerrante», o la scienza moderna, con i suoi tentativi e le sue verità.

Tentativi di soluzione
Non sono mancati tentativi di riconciliazione, come la cosiddetta teoria del «concordismo» che, di fronte alla teoria evoluzionistica di Darwin, propose di leggere il dato biblico sulla base delle conoscenze scientifiche attuali: così, per es., i sei giorni del racconto di creazione (Gn 1) andavano in realtà compresi come sei diverse epoche geologiche...
Ma la via da seguire sarà un'altra e verrà faticosamente indicata da chi, mantenendo la fede nella Bibbia come Parola di Dio, la affronterà senza rinunciare all'intelligenza critica, alle esigenze della ragione. Alla base di questo atteggiamento che si interroga sul significato, la destinazione, gli ambiti relativi alla lettura della Bibbia e alla ricerca scientifica, vi è la coscienza di fondo che la parola di Dio è parola divino/umana. Eppure, nonostante questi presupposti, altre vie imboccate dovevano risultare insufficienti. La proposta che maggiormente ebbe successo alla fine del secolo scorso, e che può apparire a prima vista convincente, è che la Bibbia è «inerrante» in tutte quelle parti che riguardano l'ambito della fede e della morale. Naturalmente una tesi del genere si scontra con il principio antichissimo e sempre ribadito che l'intera Bibbia è ispirata da Dio.

La via giusta
La via giusta per affrontare il problema della «verità» della Bibbia venne imboccata proprio grazie ad una maggiore apertura verso acquisizioni scientifiche in campo letterario che solo con fatica e tra mille perplessità iniziali furono utilizzate per la comprensione della Sacra Scrittura. Studiosi della Bibbia, soprattutto tedeschi, già dal secolo scorso fecero osservare come l'insieme dei libri che costituiscono la Bibbia appartenessero a «generi letterari» diversi, non solo, perciò, al genere «storico». Si può facilmente intuire quali fossero le conseguenze di un simile approccio all'insieme delle Sacre Scritture. È come se il lettore di quest'articolo, leggendo un qualunque libro della sua biblioteca, non avesse altro modo di leggerlo se non come libro di storia, assegnando lo stesso valore ad un romanzo, ad una novella, ad un saggio e così via.
Si pensi, per esempio, al libro biblico di Giona, il riluttante «profeta» chiamato da Dio a predicare la conversione dei peccati agli abitanti di Ninive, città simbolo della perversione dei costumi. Giona rimase per tre giorni, secondo quella narrazione, nel ventre di un pesce (Gio 2,1), per essere poi rigettato all'asciutto (Gio 2,11). Le difficoltà a considerare «storico» un simile fatto sono evidentemente enormi. Così è se non si considera che quel libro, con il suo meraviglioso messaggio di perdono divino per tutti gli uomini, non solo per gli israeliti, appartiene al genere letterario della «novella profetica» di cui si apprezza soprattutto l'aspetto didattico, l'insegnamento sulla misericordia di Dio e sull'universalità della salvezza che attraverso la novella di Giona si intende dare agli israeliti.
Ancora più chiaro per tutti noi è il caso del libro dell' «Apocalisse». Movimenti, sètte, persone di ogni tempo ne hanno frainteso e ridotto il messaggio, interpretando il libro alla lettera, come una sorta di «prima visione» di ciò che materialmente accadrà alla fine del mondo. Non hanno cioè considerato, ne lo fanno tutt'oggi i Testimoni di Geova, che il libro delle «Rivelazioni» appartiene al genere letterario «apocalittico-profetico». Caratteristica fondamentale del genere apocalittico, molto diffuso all'inizio dell'èra cristiana, è quella di utilizzare cifre, immagini, colori, descrizioni simboliche. Il lettore che voglia comprenderne il messaggio è chiamato innanzitutto a decodificare quei simboli, non ad assumerli semplicemente come la descrizione, in anteprima, di ciò che accadrà, che rimane un mistero.
Questa attenzione al genere letterario non toglie nulla alla verità del messaggio comunicato dai testi, anzi, è l'unica via per non confondere i modi di espressione con il messaggio della salvezza. Una via obbligata per distinguere il messaggio di salvezza rivelato all'uomo non solo attraverso la descrizione degli interventi di Dio nella storia (il re Davide, gli eroici Maccabei), ma anche attraverso racconti più antichi (le origini del mondo e dell'uomo di Gn 1-11, la vicenda di Giobbe o quella di Giona recuperati dall'autore sacro come mezzi per comunicare all'umanità il progetto salvifico di Dio.

La verità... per la nostra salvezza
Dalla fine del secolo scorso gli interventi di alcuni Papi sull'argomento servirono a porre degli argini a quei tentativi di soluzione alla questione della «verità della Bibbia» ritenuti insufficienti. Dalla Providentissimus Deus di Leone XIII alla Divino Afflante Spiritu di Pio XII si apriva definitivamente la strada al nuovo modo di accostare la Bibbia, mantenendo la fedeltà al principio dell'Ispirazione divina e dunque della Verità proposta da Dio all'uomo per la sua salvezza, ed aprendo il campo ad una maniera scientificamente «critica» di affrontare la Scrittura. Si giunse, così, all'accoglienza di quanto proprio le scienze letterarie offrivano agli studiosi di Sacra Scrittura per chiarire il problema: «Quindi l'esegeta cattolico, per rispondere agli odierni bisogni degli studi biblici, nell'esporre la Sacra Scrittura e nel mostrarla immune da ogni errore, com' è suo dovere, faccia pure prudente uso di questo mezzo, di ricercare cioè quanto la forma del dire o il genere letterario adottato dall'agiografo possa condurre alla retta e genuina interpretazione; e si persuada che questa parte del suo ufficio non può essere trascurata senza recare gran danno all'esegesi cattolica» (Providentissimus Deus, cf. Enchiridion Biblicum 560).
Respinte le soluzioni teologiche insufficienti, i Padri del Concilio Vaticano Il, al n. 11 della Dei Verbum, hanno presentato l'argomento in questi termini: «poiché dunque tutto ciò, che gli autori ispirati o agiografi asseriscono, è da ritenersi asserito dallo Spirito Santo, si deve dichiarare, per conseguenza, che i libri della Scrittura insegnano fermamente, fedelmente e senza errore la verità che Dio per la nostra salvezza volle fosse consegnata nelle Sacre Scritture».
Viene indicato così, dal Magistero più alto della Chiesa, che la soluzione non sta nel limitare il principio della verità biblica a una determinata parte della Sacra Scrittura, ma nell'assumere nei suoi confronti la corretta prospettiva; nel considerare, insomma, la vera finalità per la quale essa fu consegnata all'uomo.
Quella del Concilio è una parola che orienta credenti, esegeti, teologi, sgombrando il campo dai tanti equivoci a cui può condurre una maniera semplicistica o teologicamente insufficiente di parlare della «verità della Bibbia».
Sulla base dell'affermazione conciliare, che riprende ciò che è presente in maniera semplice nella fede del credente, giudeo e cristiano, appare più chiaro che la Parola di Dio, senza tentativi di armonizzazioni odi giustificazioni rispetto alle moderne conoscenze scientifiche, permette all'uomo di ogni tempo di cercare risposte alle sue domande ultime, non tanto sullo svolgimento di alcune vicende storiche, ma sul senso della storia, non sul come sia nato l'uomo e la donna ma sul mistero dell'origine, sul significato dell’esistenza e sul destino dell’uomo.
(da Parole di Vita)
La prova e l'obbedienza (a cura di Mario Maritano)
La prova e l'obbedienza
a cura di Mario Maritano
Ambrogio, discendente di una nobile famiglia romana, nato a Treviri (337/339) diede ottima prova di sé come consularis Liguriae et Aemiliae, cioè come governatore dell'ltalia settentrionale con sede a Milano. Così, pur essendo ancora catecumeno, fu acclamato vescovo di Milano dal popolo, quando egli intervenne per sedare i tumulti alla morte del suo predecessore nel 374. Iniziando il suo ministero episcopale, egli distribuì i suoi beni ai poveri, si dedicò ad una vita ascetica e si applicò agli studi teologici. Svolse un'intensa attività pastorale, sociale, a favore dei più poveri. Si rivelò abile e deciso soprattutto nel difendere la religione cattolica contro i pagani e gli eretici; affermò l'indipendenza della Chiesa di fronte allo Stato. Scrisse molte opere esegetiche, dogmatiche, morali-ascetiche, discorsi, lettere e inni.
Nel suo libro De Abraham, Ambrogio presenta la figura del patriarca come un modello di vita cristiana (ricordo che il vescovo di Milano in quest'opera si rivolge ad adulti che dovranno ricevere il battesimo). Abramo, nel suo peregrinare e nel suo agire in piena fiducia e obbedienza a Dio, diviene il modello del cristiano che progredisce spiritualmente, abbandonando una vita frivola e peccaminosa, e nelle prove e nelle tentazioni si mantiene fedele a Dio.
La prova e l'obbedienza
1,2,4. Abramo è messo alla prova come un uomo forte, è incoraggiato come un uomo fedele, stimolato come un uomo giusto e quindi "partì, secondo la parola del Signore e con lui partì Lot" (Gen 12,4). È ciò che si proclama tra le sentenze dei sette sapienti: "épou Theô", cioè "segui Dio".
Abramo con i fatti anticipò le sentenze dei sapienti, e, seguendo il Signore, uscì dalla sua terra. Ma poiché la sua terra precedentemente era un'altra, cioè la regione dei Caldei, dalla quale uscì Terach, padre di Abramo, che migrò a Carran, e poiché Abramo condusse
via con se suo nipote, mentre gli era stato detto: "Esci dalla tua parentela", (Gen, 12,1) consideriamo se per caso "uscire dalla sua terra" non significhi uscire da questa terra, cioè dalla dimora del nostro corpo, da cui uscì Paolo, che disse: "La nostra patria è nei cieli" (FiI 3,20), e dalle attrattive e dai piaceri del corpo, che - disse - sono come congiunti della nostra anima, la quale necessariamente soffre insieme al corpo, finché rimane ad esso strettamente vincolata. Perciò dobbiamo uscire dal modo di vivere terreno, dai piaceri mondani, dalle abitudini e dalle azioni della vita passata, in modo che cambiamo non solo i luoghi, ma anche noi stessi. Se desideriamo unirci a Cristo, abbandoniamo le cose corruttibili (1,2,4).
1,8,66. Dio mise alla prova Abramo quando gli ordinò di uscire da Carran e lo trovò obbediente. Lo mise alla prova quando Abramo liberò il nipote confidando nella forza della fede, quando non prese nulla del bottino (di guerra), quando Dio promise a lui, ormai vecchio, un figlio - infatti avendo egli cento anni, sebbene considerasse ormai inariditi gli organi di riproduzione di Sara, tuttavia credette e non ebbe esitazioni grazie alla fede, sebbene potesse averne a causa della sterilità e della vecchiaia (della moglie) -, lo mise alla prova sollecitando la sua ospitalità. Dopo averlo così provato, Dio reputò Abramo più forte nel sopportare ordini più impegnativi e più pesanti.
Da questo esempio impariamo che una persona è messa alla prova da difficoltà reali, è tentata invece da difficoltà create appositamente e fittizie. Dio infatti non voleva che il padre immolasse il figlio, ne che facesse questa offerta, dato che procurò una pecora da sacrificare invece del figlio, ma tentava Abramo nel suo affetto di padre (cf Gn 22,1-18), per vedere se anteponesse i comandi di Dio al figlio e diminuisse la forza della sua devozione, in considerazione del suo affetto paterno.
Ambrogio, Abramo 1,2,4 e 1,8,66
Immagini di Abramo nel Nuovo Testamento
Immagini di Abramo
nel Nuovo Testamento
Citato 73 volte nel Nuovo Testamento contro le 80 di Mosè e le 59 di Davide, Abramo è una delle più importanti figure cristiane. Lo era già negli scritti ebraici della stessa epoca. Alcune tradizioni neotestamentarie non fanno che riprendere tratti del personaggio già chiari nel giudaismo antico, trasformandoli solo in parte. Tuttavia un autore come Paolo fa del patriarca una figura originale, poco compatibile con le letture ebraiche: Abramo è per lui il giusto per fede, quindi la persona che crede in Gesù Cristo.
Le tradizioni antiche che soggiacciono al Nuovo Testamento sono difficili da individuare, perché esse sono state rimaneggiate dai redattori. Indipendentemente dall’apporto dei redattori finali e delle loro accentuazioni teologiche, tuttavia possiamo ricostruirne alcune, le cui radici affondano nel giudaismo e senza troppi rischi farle risalire a Gesù. Per un ebreo, come per un cristiano del I secolo, Abramo è l’antenato, il padre del popolo di Israele, e la paternità è inoltre una qualità che egli condivide con Dio. Egli è citato per primo nella linea dei patriarchi, perché Dio si dichiara il "Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe", formula recepita da Mosè nel roveto ardente e spessissimo ripresa in seguito (Es 3,16, citato in Mt 22,32 e paralleli; At 3,13; 7,32). Se ha lasciato il suo paese di origine, è stato per fondare un popolo e radicarlo in una terra (Gn 12,1 citato in At 7,2; Eb 11,8); i figli di Abramo formano in realtà il popolo destinatario delle promesse divine. I due cantici del vangelo dell’infanzia secondo Luca, quello di Maria e quello di Zaccaria, immersi in un’atmosfera anticotestamentaria, ricordano l’impegno che Dio si assunse di fronte ad Abramo con il popolo che doveva nascere da lui (Lc 1,55.73).
Ne consegue che ogni ebreo è figlio di Abramo, e che ogni ebrea ne è la figlia, come la donna curva che Gesù guarisce in giorno di sabato (Lc 13,16). Nelle due genealogie di Gesù, pur diverse l’una dall’altra, Abramo è citato come antenato del bambino (Mt 1,1-17; Lc 3,34). Se Matteo sfrutta l’informazione per insistere sull’appartenenza di Gesù al mondo ebraico, Luca, che la utilizza poco in questa direzione, tuttavia la fornisce;. essa fa parte del dato tradizionale cristiano. Non bisognerebbe tuttavia pensare che la filiazione da Abramo si riduca ad una situazione di fatto. Un ebreo del I secolo sa che essa è anche un divenire, e che non ci si può dichiarare figli di Abramo se non si vive della Torâ. L’alleanza stipulata con i patriarchi produce i suoi effetti soltanto se l’ebreo accetta questi padri come modelli. In vari momenti della sua crescita, l’albero dell’alleanza che ha le sue radici in Abramo ha avuto rami secchi, tra cui quelli che sono nati da Ismaele e da Esaù (At 3,25; Rm 9,7). Il primo libro dei Maccabei può scrivere: "Ricordate le gesta compiute dai nostri padri ai loro tempi e ne trarrete gloria insigne e nome eterno. Abramo non fu forse trovato fedele nella tentazione e non gli fu ciò accreditato a giustizia?" (1 Mac 2,51-52).
I vangeli testimoniano le polemiche innescate a questo proposito con alcuni ebrei, sia da parte di Giovanni Battista che di Gesù (Mt 3,9 e parallelo; Gv 8,33-40). Non basta rivendicare per padre Abramo, bisogna vivere di conseguenza. Certi paria, come Zaccheo, si rivelano veramente "figli di Abramo", mentre questo titolo era loro negato da altri che, a torto, si consideravano più qualificati di lui a portarlo (Lc 19,9).
Antenato, origine, il padre Abramo è anche naturalmente colui che accoglie i suoi figli al termine del loro cammino. Con Isacco e Giacobbe egli presiederà al banchetto escatologico cui non dà diritto la nascita (Mt 8,11; Lc 13,28). E il seno di Abramo è il luogo in cui si ritrova il povero Lazzaro della parabola (Lc 16,22-30) mentre il ricco indifferente alla sua povertà ne è escluso. Questi luoghi escatologici del vangelo legati ad Abramo sono attestati nel giudaismo rabbinico (Esodo Rabba 25; Pesiqta Gabbati 43, 108b; b. Qiddušîn 72ab). Essi corrispondono ad immagini forse comuni nel giudaismo del I secolo, benché nessun altro testo ebraico, al di fuori dei vangeli, le riecheggi direttamente.
La rivoluzione paolina:
Abramo senza Mosè
Se la figura paterna di Abramo presentata dagli evangelisti e dagli Atti degli Apostoli si inserisce, nel suo complesso, in continuità con le tradizioni ebraiche dell’epoca, non si può dire lo stesso del modo in cui Paolo tratta il patriarca. Il testo del primo libro dei Maccabei, citato prima, presenta in realtà Abramo come un modello di giustizia, ma questa giustizia gli è valsa perché è stato fedele nella prova. La prova di cui si parla è quella del sacrificio, detto anche l’Aqeda (la legatura) di Isacco riferita al capitolo 22 della Genesi. È accettando di offrire in sacrificio l’unico figlio che Abramo, nelle tradizioni ebraiche più attestate, si è rivelato giusto e fedele. Anche il Nuovo Testamento è un’eco di questo nella lettera di Giacomo e nella lettera agli Ebrei (Eb 11,17): se Abramo fu considerato giusto, non fu per la sua sola fede, ma anche per le sue opere. La lettera di Giacomo scrive: "Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere, quando offrì Isacco, suo figlio, sull’altare?" (Gc 2,21). Per questo meritò il bel titolo di "amico di Dio" (Gc 2,23; Co-rano 4,125).
Quando scrive questo, Giacomo testimonia una consolidata tradizione ebraica. Il suo testo è tuttavia segnato dalla polemica che conduce contro Paolo, che aveva della giustizia di Abramo una visione del tutto diversa. Per l’apostolo delle genti, il versetto biblico su cui si fonda principalmente la giustizia di Abramo è al capitolo 15 della Genesi: "Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia" (Gn 15,6), ben prima nel racconto della scena dell’Aqeda.
L’apostolo dedica ad Abramo due lunghi sviluppi, uno nell’epistola ai Galati (3,6-29), dove, rivolgendosi ad un pubblico tentato di sommare i comandamenti della Tora alle esigenze della vita in Cristo, Paolo insiste sul fatto che Abramo è colui che riceve le promesse divine, che queste promesse riguardano "la sua discendenza", e che il termine "discendenza" designa direttamente Cristo. Il termine "discendenza" è in realtà al singolare nel testo ebraico di Gn 12,7, come nella Settanta (Ga13,16). Cristo è dunque l’erede delle promesse fatte ad Abramo. La legge di Mosè, venuta "quattrocentotrenta anni" dopo il patriarca (Gal 3,18), non può annullare queste promesse. Di conseguenza, i comandamenti della legge ebraica non hanno peso nel processo di giustificazione del credente.
Nell’epistola ai Romani (4,1-16), gli accenti sono leggermente diversi, benché il messaggio sia complessivamente lo stesso. Paolo ricorda che Abramo fu dichiarato giusto dalla Scrittura subito dopo che Dio gli ebbe annunciato una discendenza numerosa come le stelle del cielo, nel capitolo 15 della Genesi (Gn 15,5-6). La circoncisione, figura della legge che sarebbe venuta attraverso Mosè, fu imposta da Dio soltanto più tardi, nel capitolo 17 dello stesso libro (Gn 17,10-14); ed egli superò la prova di essere stato pronto a sacrificare il figlio ancora più tardi, in Genesi 22. In altre parole: Dio dichiarò che Abramo era giusto indipendentemente dalla legge e indipendentemente dalla sua obbedienza. Non circonciso, Abramo era ancora in un certo senso pagano quando Dio lo dichiarò giusto. Questi eventi sono il fondamento della convinzione paolina che la giustizia di Dio è destinata a tutti – ebrei e pagani – grazie alla loro fede, indipendentemente dalla legge ebraica.
Il lettore moderno può essere fuorviato da questo modo di ragionare che gioca su dei particolari del testo biblico; esso è tuttavia perfettamente in linea con i criteri esegetici ebraici applicati nel I secolo. Un rabbi contemporaneo di Paolo avrebbe potuto discutere con lui di questi risultati, ma non contestare questo metodo di lettura. In un certo senso, il modo di ragionare paolino è anche straordinariamente moderno perché, nella lettera ai Romani come in quella ai Galati, Paolo tiene conto della relazione cronologica tra gli eventi: la legge è venuta dopo la promessa (mentre varie correnti del giudaismo del I secolo ritenevano che già Abramo e perfino Adamo praticassero la Tora); la giustizia del patriarca fu dichiarata dal testo sacro prima che fosse prescritta la circoncisione e prima che si fosse verificata l’Aqeda di Isacco. Prime da un punto di vista cronologico, la promessa e la giustizia nate dalla fede hanno la precedenza sugli altri eventi della storia della salvezza.
Si comprenderà così come molti ebrei non possano seguire Paolo sul suo stesso terreno, perché questo li condurrebbe a svalutare l’osservanza della Torâ, tesoro donato da Dio al popolo d’Israele. In questo, Paolo è uno dei maggiori artefici della futura frattura fra giudaismo e cristianesimo.
Una figura complementare:
Abramo, l'ebreo, sottomesso a Gesù
Non si potrebbe chiudere questa carrellata senza presentare due altri lunghi passaggi del Nuovo Testamento che mettono in scena Abramo, entrambi successivi alle lettere di Paolo: uno si trova nella lettera agli Ebrei, l’altro nel vangelo di Giovanni. Oltre alla sezione sulla fede di Abramo in cui l’autore considera due momenti importanti della vita del patriarca, e cioè la sua partenza dalla terra d’origine e il suo sacrificio (Eb 11,8-19), la lettera agli Ebrei ne ricorda un altro: l’incontro con il re sacerdote Melchisedek (Eb 7,1-9). L’autore utilizza qui la tipologia. Melchisedek è typos di Cristo; il suo sacerdozio prefigura il sacerdozio della nuova alleanza. Quanto ad Abramo, egli è l’antenato di Levi, portatore lui stesso del sacerdozio ebraico. Ora il testo afferma che Abramo attribuì a Melchisedek "la decima di tutto", lo considerò cioè suo superiore e si sottomise a lui (Gn 14, 17-20). Trasferendo questo al rapporto tra Gesù e i sacerdoti ebrei, l’autore della lettera ne deduce la superiorità del sacerdozio di Cristo sul sacerdozio levitico, benché Gesù non fosse appartenuto, secondo la legge ebraica, ad una famiglia sacerdotale. Gesù corrisponde a Melchisedek, Abramo a Levi.
Di redazione ancora più tardiva, il vangelo di Giovanni dedica un lungo passaggio ad una polemica tra Gesù e coloro che l’evangelista chiama "i Giudei", nella quale interviene la figura di Abramo (Gv 8,33-58). Questi ultimi affermano all’inizio della discussione: "Il nostro padre è Abramo" (v. 39). Sino a questo punto, non è che una discussione diffusa, già richiamata, sul diritto di qualcuno di rivendicare Abramo per padre. La sfumatura propriamente giovannea si precisa tuttavia lungo lo svolgimento del racconto. Alcuni versetti più avanti, Gesù dichiara: "Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e se ne rallegrò" (v. 56); poi: "In verità in verità vi dico: prima che Abramo fosse, Io sono" (v. 58). Dichiarazione che i suoi interlocutori considerano blasfema e a conclusione della quale raccolgono pietre per scagliarle contro l’empio. Come appare da questo complesso sviluppo, il personaggio di Abramo cambia statuto: dalla figura paterna che è all’inizio della discussione, diventa una figura profetica la cui funzione è testimoniare la preesistenza del Figlio e di rallegrarsi della sua venuta.
Queste due ultime figure, presentate rispettivamente dalla lettera agli Ebrei e dal vangelo di Giovanni, hanno in comune che Abramo è sottoposto a Cristo: sottoposto attraverso la sua riverenza verso Melchisedek (Eb), sottoposto grazie alla gioia che egli prova nel "vedere" colui il cui nome è "Io sono" (Gv).
Modello per il credente di ogni origine (ebreo o pagano) secondo Paolo, Abramo avrebbe potuto diventare nel pensiero cristiano una pura figura di universalismo. Testi posteriori alle lettere paoline, e in particolare i vangeli di Matteo e di Giovanni come pure la lettera agli Ebrei, lo reinseriscono tuttavia nel giudaismo, col rischio di ridurne in parte la statura. Questa diversità ristabilisce un felice equilibrio. Paolo sceglie Abramo piuttosto che Mosè, Matteo al contrario valorizza Mosè e la sua legge. Giovanni tratta il patriarca come un profeta.
Gli autori del Nuovo Testamento si impadroniscono delle figure dell’Antico con grande libertà, contribuendo tutte a delineare i tratti di colui in cui essi trovano la loro pienezza, cioè Gesù Cristo.
1. Che cosa è la Bibbia (Rinaldo Fabris)
L'espressione italiana: “La Bibbia”, viene da un plurale greco tà Biblía, “i libri”, passando attraverso il latino medievale Bíblia.