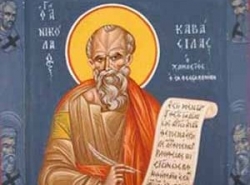Mondo Oggi

Fausto Ferrari
Religioso Marista
Area Formazione ed Area Ecumene; Rubriche Dialoghi, Conoscere l'Ebraismo, Schegge, Input
Il rito comunitario della penitenza (Rinaldo Falsini)
Tre sono i riti di riconciliazione: il primo per i singoli penitenti, il secondo per più penitenti con confessione e assoluzione individuale, il terzo per più penitenti con confessione e assoluzione generale.
L’identità teologale dell'etica cristiana (Giannino Piana)
L’identità teologale dell'etica cristiana
di Giannino Piana
I documenti del Magistero non si rivolgono solo ai credenti e fanno spesso riferimento ad un ordine naturale che ha radici nella coscienza umana.
La morale cristiana è una semplice morale umana o è qualcosa di più e di diverso Esiste, in altre parole, una differenza sostanziale tra il comportamento puramente umano e quello del credente E, sé esiste, dove sta tale differenza? Questi interrogativi sono venuti affiorando, con sempre maggiore insistenza negli ultimi decenni, non solo nell’ambito della ricerca teologica, ma anche all’interno della stessa coscienza dei credenti. A favorirne la nascita hanno concorso un insieme di fattori legati tanto alle trasformazioni del contesto socio-culturale quanto al rinnovamento dell’etica cristiana. Tra essi merita anzitutto di essere ricordato il fenomeno della secolarizzazione, che ha provocato una graduale emancipazione dell’uomo e del mondo dall’universo simbolico sacrale da cui sembravano dipendere. L’agire umano è venuto di conseguenza sempre più configurandosi come agire autonomo, le cui motivazioni ed i cui significati possono essere rintracciati dall’uomo a partire dalla propria ragione e da una corretta interpretazione della realtà storica. L’etica appare dunque essenzialmente come un dato umano, come lo spazio nel quale ogni uomo è chiamato a costruirsi responsabilmente il proprio destino in stretta relazione con gli altri e con il mondo.
D’altra parte, la stessa riflessione morale cristiana, stimolata da una più attenta rivisitazione dei testi biblici, ha progressivamente ricuperato il fondo umano che sta alla radice dell’agire dei credenti. Molti dei valori e delle norme contenuti nella rivelazione, sia dell’Antico che del Nuovo Testamento, altro non sono che la trasposizione, nel quadro della storia della salvezza, di una sapienza umana diffusa, che ha la sua sorgente nel piano originario della creazione. È significativo che gli stessi documenti del magistero - soprattutto quelli di carattere sociale - non si rivolgano esclusivamente ai cristiani ma a tutti gli uomini di buona volontà e facciano spesso riferimento ad un ordine naturale, che ha le sue radici nella coscienza dell’uomo.
Questa riscoperta di un patrimonio comune costituisce senz’altro un elemento positivo e di grande interesse. Consente infatti di riaprire un confronto e di dar vita ad una feconda collaborazione tra credenti e non credenti in nome di un convergente interesse per l’uomo e per la sua liberazione. Ciò non significa tuttavia che si debba negare l’originalità della morale cristiana, significa piuttosto che tale originalità va ricercata in un più vasto orizzonte di interpretazione del senso dell’agire. A questo orizzonte, ricco di profonde implicazioni, ci rinvia la recente e densa opera di Mauro Cozzoli (Etica teologale. Fede, carità, speranza, Edizioni Paoline, Milano 1991), che individua nella vita teologale l’elemento nuovo e fondativo dell’agire morale del cristiano.
Fede, carità e speranza, nel rapporto costitutivo che le unisce, sono modi di essere strutturali e dinamici che permeano di sé l’intero esistere umano e coinvolgono tutto l’agire. Attraverso di esse ha infatti luogo la partecipazione alla vita divina che si realizza nell’incontro tra il dono di Dio e la libera accoglienza dell’uomo. L’identità della morale cristiana non va dunque anzitutto ricercata sul terreno della definizione dei significati immediati dell’agire, ma su quello della determinazione del suo senso ultimo. La fede acquista, sotto questo profilo, il carattere di centro di unificazione e di irradiazione della vita morale e assolve la funzione di criterio ultimo di discernimento delle diverse situazioni dell’esistenza quotidiana. L’incontro con Gesù, in quanto evento trasformatore e datore di senso, è lo specifico morale del cristiano.
Il dovere etico, lungi dal risuonare come un’imposizione, appare piuttosto come esigenza da accogliere e come compito da eseguire nella fedeltà. In quanto opzione decisiva di tutta l’esistenza, la fede coincide con la libertà fondamentale della persona sollecitata a rispondere all’iniziativa divina, abbandonando la presunzione dell’autogiustificazione e convertendosi alla radicalità del messaggio evangelico.
Il cuore di questo messaggio è il grande comandamento dell’amare. Esso ha il suo fondamento e riceve il suo senso dalla partecipazione alla carità di Dio, cioè alla comunione che unisce il Padre al Figlio nello Spirito. L’inserimento dell’uomo nel dialogo trinitario dell’agape contrassegna la sua nuova condizione di creatura e di figlio di Dio e costituisce lo statuto ontologica della sua esistenza che deve interamente svilupparsi nell’amore. Il mistero trinitario diviene così il modello cui l’uomo è chiamato ad ispirare la propria condotta: un modello i cui connotati sono la donazione totale di sé, l’accoglienza incondizionata dell’altro e la piena comunione da realizzare nel superamento di ogni chiusura e nell’accettazione radicale della diversità.
La croce di Cristo è il luogo a cui soprattutto riferirsi per attingere la specificità dell’amore cristiano come gratuità e pura benevolenza, come totalità e sovrabbondanza che supera ogni bisogno umano e travalica tutti i confini. Il vangelo della carità è pertanto la nuova legge della grazia che lo Spirito scrive nel cuore dell’uomo. Essa spinge chi la riceve a rendere trasparente nella vita quotidiana l’amore verso Dio e verso il prossimo, in quanto aspetti inscindibili dell’unico precetto. Non si dà infatti amore vero per l’uomo senza Dio, ma neppure amore autentico per Dio a prescindere dall’uomo, che ne riflette immediatamente l’immagine
Testimoni di speranza
Ma la fede e la carità non stanno senza la speranza, che è la tensione escatologica della vita cristiana. Essere discepoli di Gesù significa infatti diventare testimoni credibili della speranza, la quale non va considerata come una proiezione spiritualistica che distoglie l’uomo dalle responsabilità secolari, ma come una forza sollecitatrice dell’impegno per il mondo. In quanto assunti nel dinamismo salvifico di Cristo, creazione e storia sono sottratte al determinismo e coinvolte nel processo di liberazione già in atto, e tuttavia aperto al futuro assoluto. La speranza è dunque la molla dell’agire morale del credente. La promessa del Signore obbliga il cristiano a calarsi dentro la storia, vivendo la ricerca di un equilibrio sempre nuovo tra la passione del possibile e l’attesa del giorno del Signore. Essa conferisce soprattutto senso alla libertà dell’uomo, spingendolo ad assumersi fino in fondo le proprie responsabilità e ad accettare anche gli inevitabili scacchi.
La vita teologale è perciò, in definitiva, ciò a cui occorre risalire se si vuole cogliere la novità della morale cristiana. Essa confluisce nell’azione liturgico-sacramentale come momento nel quale si attua, nel modo più completo, la partecipazione del cristiano alla vita di Cristo. Qui infatti l’indicativo di salvezza trova la sua ragione ultima per dispiegarsi in imperativo di salvezza, cioè in esigenza di vivere in fedeltà alla logica del regno. Ma il rischio laddove manca la vita teologale è che tale momento si inaridisca trasformandosi in rito vuoto e in atteggiamento devozionalistico e che la vita morale si secolarizzi e si privatizzi.
2) Cristo unico sacerdote della Nuova Alleanza (Marino Qualizza)
6. Sacerdozio battesimale
e ministeriale
di Marino Qualizza

2. Cristo unico sacerdote della Nuova Alleanza
Per i cristiani parlare di Cristo come unico sacerdote del NT è una cosa non tanto ovvia, in quanto hanno dinanzi a sé l’immagine di tanti sacerdoti e vescovi, cosicché per loro è chiaro piuttosto il contrario. I sacerdoti sono tanti, perché il popolo di Dio è numeroso e diffuso in tutto il mondo. Eppure questa non è la verità, perché nel NT c’è un unico sacerdote, in quanto è l’unico che abbia potuto compiere ciò che si richiede al sacerdote: stabilire il rapporto fra Dio e gli uomini. L’unicità del sacerdozio di Cristo è fondata sulla identità personale di Cristo, sul suo essere il Verbo di Dio fatto uomo. In questo senso dobbiamo dire che Cristo non è solo l’unico sacerdote del NT, ma di ogni possibile sacerdozio, perché in nessuna religione è possibile stabilire il rapporto con Dio. Al massimo si può esprimere un desiderio, una preghiera, ma la realtà è più alta e più ardua. Il desiderio perenne dell’umanità di raggiungere Dio e il suo mondo è stato realizzato in modo inaudito e fantastico nella persona di Gesù il Cristo. Proprio perché egli è il Figlio di Dio e proprio perché è diventato uno di noi, ha realizzato nella sua persona e poi nell’opera che ha compiuto sulla terra quanto l’umanità intera da sempre ha sognato.
2. a. Originalità della lettera agli Ebrei
Non sono molti i testi che si occupano del sacerdozio di Cristo; in realtà uno solo, la lettera agli Ebrei, come è già stato ricordato. <<La legge infatti non condusse nulla a perfezione. Invece è stata fatta entrare nel mondo una speranza superiore, per la quale ci avviciniamo a Dio…E quelli sono divenuti sacerdoti in molti, perché la morte impediva loro di rimanere. Questi invece, per il fatto che rimane in eterno, ha un sacerdozio non trasmissibile. Onde può anche salvare per sempre quelli che, mediante lui, si avvicinano a Dio, essendo sempre vivente per intercedere in loro favore>> (7, 19.23-25).
Intanto una affermazione di grande rilievo e di fortissimo impatto: la legge non condusse nulla a perfezione. Se essa fu incapace di portare alla perfezione, pur essendo un dono divino, è chiaro che ancora meno potevano le altre istituzioni religiose dell’umanità; salva la loro buona volontà. Ritroviamo qui un pensiero familiare a san Paolo sul tema della giustificazione: questa non viene dalla legge. Ma poi il discorso continua e coinvolge anche i sacerdoti dell’AT. In altre parole, risulta chiaro quanto da sempre afferma la teologia della grazia, sulla base di un semplice ragionamento: la creatura non può mai raggiungere il Creatore, se questi non le si dona in modo gratuito e libero. Il primato della grazia non è un dogma così arduo, perché il semplice buon senso lo fa capire e accettare.
2. b. Unicità e originalità del sacerdozio di Cristo
Nel caso specifico del sacerdozio della Nuova Legge, il discorso del testo agli Ebrei si rifà ad una constatazione che è sotto gli occhi di tutti: ‘la morte impediva loro di rimanere’. La funzione di un sacerdote, secondo la logica biblica, è quello di intercedere per sempre. Dunque l’intercessione è quanto individua e specifica il compito di un sacerdote. Finché esiste questo mondo di essa si avrà sempre bisogno. Ma chi può garantire una intercessione perenne, se non chi ha in sé la vita imperitura? La tesi del testo biblico è del tutto coerente e logica: nel NT non ci possono essere altri sacerdoti, se non il Cristo Signore, perché in forza della sua vita immortale rende superfluo il compito di altri sacerdoti. E la tesi è ribadita con un nuovo argomento, quando si dice: <<(Cristo) dopo aver offerto un unico sacrifico per i peccati, si è assiso per sempre alla destra di Dio, aspettando che i suoi nemici siano posti sgabello ai suoi piedi. Infatti con unica oblazione ha reso per sempre perfetti quelli che vengono santificati>> (10, 12-14).
Intercede in nostro favore assiso alla destra di Dio. Chi può vantare un tale titolo ed una tale intercessione? Ci sono due concetti che si inseguono: l’intercessione perenne e la santificazione perfetta. Sembrerebbe, a prima vista, che la santificazione perfetta rendesse inutile l’intercessione, ed invece restano assieme l’una e l’altra, perché ciò che è reso perfetto una volta per sempre, ha bisogno di essere distribuito nel tempo della storia. C’è da fare una ulteriore osservazione a questo proposito. Il testo citato Eb 7,24 nella versione delle Edizioni Paoline, parla di un sacerdozio ‘non trasmissibile’, quella della CEI invece parla di un sacerdozio ‘che non tramonta’. Il traduttore S. Zedda gioca abilmente sul termine greco, che in senso traslato può essere espresso anche come ‘non trasmissibile’. Si dice infatti che è ‘aparàbaton’. I cultori del greco potranno approfondire le cose.
2. c. Sacerdozio unico e partecipato
Ma per quel che ci riguarda, la cosa non è senza importanti significati. Se si tratta di sacerdozio unico, è evidente che non è trasmissibile, perché altrimenti perderebbe la sua unicità. Qui però potrebbe insinuarsi un dubbio di non lieve entità: dunque quelli che noi chiamiamo sacerdoti cristiani oggi, in realtà non lo sono, anzi appaiono addirittura degli usurpatori. È noto che questa è stata una interpretazione di alcuni Riformatori del XVI secolo. Non è detto che si debba leggere così. Infatti se il sacerdozio unico di Cristo non può essere trasmesso, può essere partecipato, nella linea sacramentale. Infatti è questa che da una parte congiunge con Cristo e dall’altra relativizza o ridimensiona il ruolo dei ministri del NT. Non si tratta di una identificazione fisica con Cristo, nel senso di una formula che si presta ad equivochi: ‘sacerdos alter Christus’, ma di una comunione nella linea sacramentale appunto, che dice partecipazione e differenziazione. La linea sacramentale è quella che impedisce ogni esagerazione ed ogni negazione. Non sostituiamo Cristo, né siamo soltanto dei portavoce, ma siamo veramente uniti a lui, mediante lo Spirito, rendendolo presente nel nostro tempo, in forza di ciò che i sacramenti significano e realizzano. Se non siamo il Cristo, lo rendiamo presente nella storia di oggi nella forza dello Spirito Santo. Dunque, è sempre lui che salva e redime e santifica, secondo la splendida teologia di sant’Agostino: Pietro battezza? Giuda battezza? È sempre Cristo che battezza.
2. d. Compiuto nel santuario di Dio
E l’ultima attestazione del sacerdozio unico di Cristo è dato da Eb 9, 11-12.15 :<<Cristo, però, apparso come sommo sacerdote dei beni futuri, per una tenda più grande e perfetta, non manufatta, cioè non di questa creazione, né mediante sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue è entrato nel santuario una volta per tutte, perché ha trovato un riscatto eterno…Perciò egli è il mediatore dell’alleanza nuova, affinché, essendo intervenuta una morte in redenzione delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, i chiamati ricevessero la promessa dell’eterna eredità>>.
Il sommo sacerdote entrava una volta nel santuario del tempio per chiedere il perdono dei peccati di tutto il popolo. Cristo è entrato in un altro santuario, quello del cielo; dunque la sua mediazione, la sua opera non è simbolica, ma reale; è giunto nel santuario di Dio, presentando a lui la lista dei nostri peccati e ottenendone il perdono. Solo lui è giunto al trono di Dio, perché egli è venuto da questo trono, in quanto Figlio. Questa è dunque la novità che fonda la redenzione definitiva e la nuova alleanza. Quindi è il mediatore unico della nuova alleanza, per tutti i motivi già detti. Tuttavia, questa unicità non è la chiusura per una mediazione che perdura nel tempo, in virtù della Pasqua di Cristo,come testimonia san Paolo: <<E tutto ciò è da Dio, il quale ci ha riconciliati con sé mediante Cristo, ed ha affidato a noi il ministero della riconciliazione; è stato Dio, infatti, a riconciliare con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. Noi fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo, ed è come se Dio esortasse per mezzo nostro>> (2Cor 5, 18-20).
L’opera unica di Cristo è resa presente da coloro che sono stati resi ambasciatori di Cristo Signore e dell’opera della riconciliazione.
Fasi della cultura europea d'oltralpe. Attualità: la grande svolta (Renzo Bertalot)
Attualità: la grande svolta
di Renzo Bertalot

A - I teologi
Nel 1957 Hans Küng pubblicava la sua tesi di dottorato presso l'università Gregoriana di Roma discutendo il tema della giustificazione per fede in un confronto diretto con la teologia di Karl Barth. Le convergenze emergenti erano di una tale entità da sorprendere gli studiosi sia cattolici sia protestanti. Barth stesso era stato richiesto di fare la presentazione alla dissertazione del candidato dando un suo giudizio. L'apprezzamento del teologo di Basilea non poteva venire espresso in maniera più chiara: "lei mi fa parlare come parlo io e...io penso come lei mi fa parlare". La ricerca accurata e il coraggio determinante mettevano in evidenza la convergenza dei rispettivi pensieri. "Se" tale interpretazione cattolica della giustificazione per grazia mediante la fede si dimostrasse effettivamente coerente con il sistema dogmatico di Roma a Karl Barth non resterebbe altra possibilità se non quella di ritornare a Trento per dire ad alta voce: Patres peccavi. Le contrapposizioni tradizionali si rivelavano quindi come un "continuato malinteso". Le due chiese non avrebbero più dovuto considerarsi "alternative", ma come espressioni diverse della stessa fede. (1)
Nel 1969 la tesi di H. Küng, con la prefazione di K. Barth, veniva pubblicata in italiano. J. L. De Vitte, professore di teologia controversista della Pontificia Università Gregoriana, segnalava le osservazioni generalmente positive che circolavano sull'argomento. (2) Dopo secoli di polemiche si apriva uno squarcio di sereno. Era la grande svolta, una pietra nello stagno immobile degli arroccamenti passati. Si parlava ampiamente del "malinteso" di Trento mentre il Concilio Vaticano II era in pieno svolgimento.
Tuttavia non tardarono le resistenze e ripresero fiato le affermazioni sulle chiese "alternative", sulle "scelte" inevitabili, sui nuovi "orientamenti" e sulle "linee politiche" imposte dalla guerra fredda. Fu un momento difficile per quanti prestavano attenzione alle tesi del "dialogo" in vista del superamento del "monologo" a forte matrice integrista. L'"aut-aut" tornava ad incidere sui contenuti anziché sulla necessità di distinguere tra il fondamento e la forma per non contrabbandare il vaso d'argilla con il messaggio da trasmettere. Il dialogo infatti, dopo mezzo secolo di incontri tra le chiese, era un occasione da non perdere: non bisognava cedere frettolosamente alla tentazione di accantonarlo.
Intanto la contestazione giovanile dell'establishment che si era sviluppata a partire dal 1967 all'università americana di Berkeley (California), si tinse di rosso cupo in Europa e sotto la spinta del vento caldo, proveniente dalla Cina, stimolò alcune frange estremiste a criticare Stalin addirittura da sinistra. Non di rado la sopravvivenza del dialogo veniva paragonata a neutralità disimpegnata e le si attribuiva poco generosamente il marchio dell'infamia.
Certamente c'è da chiedersi se K. Barth e P. Tillich, così notevolmente aperti alle idee socialiste, non siano giunti alla fine della vita con qualche dubbio sulla loro fatica a proposito degli ultimi eventi storici loro contemporanei.
B - I dialoghi
Intanto nel 1968 ad Uppsala ebbe luogo la IV Assemblea del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Un tema molto difficile da affrontare era quello della "cattolicità" della chiesa: ogni settore del cristianesimo presente lo rivendicava come una nota caratteristica della propria identità confessionale. Il cosiddetto "miracolo" di Uppsala propose una transizione comune dalla nozione di "cattolicità esclusiva" ad una "cattolicità inclusiva" e quindi aperta al futuro e soprattutto alla missione. Nel contesto si chiarì che ogni "dono" di Dio comporta un "compito" per chi lo riceve (Gabe und Aufgabe). Non sono pensabili l'uno senza l'altro!
La discussione presente sulla giustificazione per fede e gli approfondimenti futuri potranno facilmente richiamarsi a questi orientamenti ecumenici incipienti.
Nel 1972 ebbe luogo a Malta un incontro tra cattolici e luterani sul tema della giustificazione per fede. Il documento conclusivo evidenziava le prospettive convergenti e stimolava la continuazione dei lavori nonostante le critiche degli assenti. (3) Per H. Küng era invece un momento felice. Una volta messo in risalto l'essenziale sarebbe stato possibile accompagnare K. Barth a Trento affinché potesse finalmente mantenere la sua promessa e dire ad alta voce: Patres peccavi. Purtroppo Barth era morto quattro anni prima e il dialogo sulla grande svolta rimase interrotto. (4)
Nel 1997 il dialogo cattolico luterano presenta un documento finale sul tema della giustificazione per fede in vista di un accordo definitivo. Le controversie tradizionali sono ricondotte ad una questione di "forma" al di là della quale emerge un "fondamento" comune fortemente marcato e decisivo per entrambe le parti. (5) Tra l'altro si affermava la nostra totale dipendenza dalla grazia salvatrice e non dalla nostra libertà personale. Siamo, infatti, incapaci di convertirci a Dio, di meritare la giustificazione e di ottenere la salvezza tramite i nostri meriti.
Per i cattolici la "cooperazione" veniva intesa come "effetto" della grazia e non della nostra abilità. Per entrambe le parti si poteva affermare che tutto ciò che precede e segue il dono di Dio non costituisce la base della giustificazione e dei meriti. Le scomuniche tradizionali non avrebbero più avuto ragione di sopravvivere in rapporto allo specifico accordo raggiunto.Non mancarono riserve da parte di un folto gruppo di teologi luterani e anche da parte riformata, (6) ma la Federazione Mondiale Luterana approvò il documento.
C - La svolta
In data i settembre 1998 si ebbe la risposta ufficiale da Roma. Si rendeva necessario un ulteriore chiarimento sulle questioni di vocabolario (l'espressione iustus ac peccator e il concetto di "penitenza"), per stabilire un rapporto corretto con la regula fidei e l'autorità del consenso proposto. Si doveva forse registrare dopo 450anni da Ratisbona un persistente cono d'ombra? Non fu così. Tutto poteva essere confermato con la sola aggiunta di un allegato al testo ufficiale. L'allegato venne e fu accettato ufficialmente l'11 giugno 1999. (7) La firma del documento finale avvenne il 31 ottobre 1999, durante le celebrazioni della domenica della Riforma, ad Augusta, città storica del protestantesimo, dove fu stesa la Confessione detta appunto "augustana" del 1530.
Si tratta evidentemente di un salto di qualità (è il primo dialogo "recepito") verso il Terzo Millennio che ci vedrà impegnati nei vari settori del cristianesimo per trarne le conseguenze sul piano teologico e pratico. Intanto cattolici e luterani possono definire, sia pure con sottolineature diverse, l'uomo simul peccator et iustus affermando che "noi siamo in verità interiormente rinnovati dall'azione dello Spirito Santo, restando sempre dipendenti dalla sua opera in noi" e contemporaneamente "se diciamo di essere senza peccato non siamo nel giusto". (8)
È ancora prematuro prevedere il rinnovamento dei dialoghi che la "dichiarazione congiunta" comporterà nell'area del movimento ecumenico. Possiamo solo anticipare le prime reazioni da parte cattolica che leggono nel documento firmato ad Augusta un "consenso differenziato" e "un'interpretazione autentica" di quanto il concilio di Trento aveva deliberato in proposito.
Possiamo anche aggiungere una domanda autorevole da parte luterana: .... il mistero dell'unica chiesa di Cristo può essere espresso attraverso un altro approccio ecclesiologico, un'altra teologia del ministero, un altro apprezzamento delle strutture ecclesiali? Resta il fatto che la questione posta è appunto quella della legittimità di un approccio ecclesiologico diverso dalla mia tradizione". (9)
Se ci si chiede se sia possibile una 'riconciliazione senza capitolazione', da parte autorevole cattolica si risponde: "La dichiarazione congiunta offre una risposta positiva a questo interrogativo". (10)
A distanza di tanti anni credo che sia doveroso non dimenticare quanti hanno lavorato e sperato di vedere questo momento. In modo particolare il nostro pensiero va ancora al cardinale Gasparo Contarini, patrizio veneziano.
Note1) Sull'"immenso e tragico malinteso di Trento" cf. J. De Senarclens, Héritiers de la Réformation, Labor et Fides, Ginevra, 1959, p. 163. Per quanto riguarda il rapporto tra giustificazione e santificazione, vedi J. Moltmann, Lo spirito della vita, Queriniana, Brescia, 1998.
2) H. Küng, La giustificazione, Queriniana, Brescia, 1969, pp. 389ss.
3) Sono “consensi che commuovono gli inconsapevoli", e un “ricorso storico di un'antica incomprensione", cf. V. Subilia, La giustificazione per fede, Paideia, Brescia, 1976, p. 114.
4) H. Küng, Karl Barth and the Postmodern Paradigm, in The Princeton Seminary Bullettin, n.l, (1988), p. 16.
5) Joint Declaration on the doctrine of Justification, World Lutheran Federation, Ginevra, 1997.
6) Dubbi sul "pieno consenso" furono espressi da parte valdese, cf. Riforma dell'11 settembre 1998. Va inoltre ricordato che per Calvino i bambini dei credenti sono battezzati perché cristiani e non sono cristiani perché battezzati, G. Calvino, I.C.R. IV, XV, 22. Per U. Zwingli la salvezza dipende dall'elezione, non dai sacramenti. Per M. Lutero, cf. G. Ferrari (a cura di), Lutero. Opere scelte. 9. I Concili e la Chiesa 1539, Claudiana, Torino, 2002. L'acqua per mezzo della Parola di Dio diventa battesimo, p.351. Ilbattesimo comunica la salvezza, p.51.
7) Così alla conferenza stampa, tenutasi a Ginevra presso il Centro Ecumenico in data 11 giugno 1999, presieduta dal past. Ishmael Noko, segretario generale della Federazione Mondiale Luterana, e dal cardinale Edward Idris Cassidy, presidente del Pontificio Consiglio per l'unità dei cristiani.
8) Cf. intervista al card. Joseph Ratzinger, prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, e a Eero Huovinen, vescovo luterano di Helsinki, in 30 Giorni, n.6, 1999, p. 19.
9) A. Birmelé, La dichiarazione congiunta luterano-cattolica sulla giustificazione. Un cammino di pace tra le chiese (I), in Av.Vv., Conflitti violenza pace: sfida alle religioni, Ed. Ancora, Milano, 2001, p. 76. André Birmelé, teologo luterano, è docente all'Istituto di Ricerca Ecumenica di Strasburgo.
10) A. Maffeis, La dichiarazione congiunta luterano-cattolica sulla giustificazione. Un cammino di pace tra le chiese. (Il), in Ib., p 88. Angelo Maffeis, teologo cattolico, è docente alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e membro di Fede e Costituzione.
Il 6 settembre 2000 usciva la Dichiarazione Dominus Jesus del cardinale Ratzinger che ci invita a riflettere in modo esclusivo sulla "perfezione" della chiesa di Cristo, perfezione che si trova "soltanto" nel cattolicesimo. Ha sollevato logicamente forti reazioni sia all'interno che all'esterno del mondo cattolico. È un forte richiamo al punto di partenza e anche un invito a non trasformare i dialoghi in utopia per non perdersi in un labirinto di intuizioni senza uscita.
Molto interessante è il suggerimento di Paul Ricoeur, cui è stato attribuito il "Premio Internazionale Paolo VI" in data 5 luglio 2003, di prestare maggior attenzione al dialogo in quanto linguaggio. Si tratta infatti di imparare una lingua straniera e di cercare di tradurla nel proprio ambito confessionale. Cf. P. Ricoeur, Dal Concilio di Trento al Convegno di Trento, in G. Breschin-E. Cambi-L. Cristellon, Lutero e i linguaggi dell'Occidente, Morcelliana, Brescia, 2002, pp. 17-24.
Nicola Cabasilas, il laico che fu maestro di spiritualità (Marco Ronconi)
Nicola Cabasilas,
il laico che fu maestro di spiritualità
di Marco Ronconi

Nicola Cabasilas (1322-1391/97), santo della Chiesa bizantina, ha goduto nella cristianità latina una notevole e per certi versi curiosa autorevolezza, che non sembra fortunatamente declinare. I suoi testi - di un autore non cattolico - sono stati utilizzati sia al Concilio di Trento, sia al Vaticano Il. Senza volontà di precisione, si trovano sue citazioni in Jacques-Bénigne Bossuet, Giuseppe Dossetti, Joseph Ratzinger, Paolo VI e Giovanni Paolo Il. A un suo passo si è rifatto il Predicatore della Casa Pontificia lo scorso venerdì santo, mentre il suo nome è presente in Orientale Lumen e nella più recente enciclica Ecclesia de Eucharestia. Anche l’ultimo convegno ecumenico tenutosi al monastero di Bose lo scorso settembre, ha analizzato la figura di questo laico cristiano, che vale forse la pena conoscere più a fondo.
Tutta l'esistenza di Maria sotto l'azione vivificante dello Spirito (Francesco Pio Tamburrino)
Scelte radicali (Faustino Ferrari)
Dovremmo tornare a focalizzarci sulle esigenze della vita evangelica. Quelle esigenze che interpellano tutti nella loro radicalità e non soltanto alcuni privilegiati...
Gesù nelle grandi confessioni e nelle ideologie (Bruno Secondin)
Gesù nelle grandi confessioni
e nelle ideologie
di Bruno Secondin

ISLAM
Gesù rimane sempre «sorpassato» da Maometto, l’ultimo e il più grande dei profeti. Ancora oggi non è assolutamente ammissibile per l’islam non solo l’incarnazione nel tempo del Dio unico e invisibile; ma anche la morte in croce del Figlio di Dio. Un profeta non può essere lasciato da Dio nell’umiliazione.
È importante notare che ciò che l’islam pensa e crede di Gesù è radicato in certi capitoli del Corano, in particolare quelli che trattano di Gesù e della sua madre Maria. Essi rimangono ancora oggi fattore determinante e centrale del giudizio islamico su Gesù Da qui deriva una notevole stima sia del cristianesimo - considerato religione rivelata da Dio - che di Cristo, considerato mandato da Dio, taumaturgo, originato da nascita verginale, portato in cielo col corpo (ma senza soffrire la morte).
Maria è l’unica donna citata per nome nel Corano - da lei prende nome perfino un capitolo del testo - e che insieme a Cristo ha goduto di particolare simpatia e venerazione nei secoli tra i musulmani1. Ma sempre alla luce e nell’orizzonte generale di quello che il Corano dice di loro.
Nel Corano sono anche descritte qualità distintive dei «seguaci di Cristo»: mitezza e misericordia, assenza di superbia, attenzione ininterrotta alla preghiera, liberalità nelle elemosine e attesa dell’ultimo giorno. In questo senso di vita cristiana come «ascesa» mediante la povertà, la mitezza e l’umiltà si è anche sviluppata e tramandata l’immagine di Gesù nell’islam.
Inoltre oggi si tende a studiare ancor di più la «cristologia» del Corano perché la sua «teologia» riflette la posizione del giudeo-cristianesimo: cioè la cristologia siriaca e semitica dei primi secoli (che privilegia la categoria del servo, come appunto fa il Corano), che poi abbiamo perduto, con la «ellenizzazione».
Un fatto nuovo rispetto alla storia è l’attuale interesse nell’islam per il così detto Vangelo di Barnaba: un testo italiano e spagnolo, databile al secolo XVII (edito però in questo secolo), ma che pretende essere una traduzione di un testo scritto al tempo di Gesù, dal suo discepolo Barnaba. Ciò che ci interessa è come Gesù è presentato: è un Gesù musulmano, ma in stile simile a quello dei Vangeli canonici cristiani. Non contiene nulla che sconcerti un musulmano: né la divinità di Gesù, né la crocifissione, né affermazioni che non siano nell’ortodossia del Corano. C’è di più: l’annuncio chiaro ed esplicito della venuta d’un profeta dopo Gesù, con la rivelazione perfetta2.
Ma se nel Corano Gesù viene chiamato «Parola» di Dio e annunciatore del «Vangelo», come possono i musulmani disinteressarsi di questo Messia e del suo Vangelo?
Fra i teologi musulmani, citiamo Mahmoud M. Ayoubl
«Noi vediamo perciò che - come il Cristo della fede e della speranza cristiana - il Gesù del Corano e della successiva pietà musulmana è molto più di un semplice essere umano e di un semplice banditore di un libro. Mentre il Gesù dell’islam non è il Cristo della cristianità, il Cristo del Vangelo parla spesso attraverso il semplice, umano Gesù della pietà musulmana»3.
Purtroppo le attuali situazioni di conflitto e di tensione fra nazioni cristiane/occidentali e nazioni/culture islamiche hanno fatto crescere tra i musulmani un fondamentalismo esasperato, che non c’era nella storia passata, in questa forma almeno.
Note
(1) Un recente interessante contributo in Maria nell’ebraismo e nell’islam oggi, Marianum-EDB, Roma-Bologna 1987.
(2) Il testo: L. CIRILLO-M. FREMAUX, Évangile de Barnabé Recherches sur la composition etl’origine. Texte et traduction, Paris 1977. Una valutazione cristiana:.J. SLOMP, The Gospel in Dispute. A crirical Evaluation of the first french Translation, with the italian Text and Introduclion of the so-called Gospel of Barnabas, in «Islamocristiana», 4(1978), pp. 67-111.(3) E’un noto teologo musulmano, che ora vive in America. La frase è ripresa da un suo saggio in «The Muslim World» 66(1976), p. 187.

BUDDISMO
Gesù appare una grande «personalità», supremo maestro della via alla saggezza sconosciuta, che ha tante somiglianze con Budda4. E un’ammirazione che però non intende accettare gli aspetti «divini» di Gesù. Si tace di fronte alla «divinità per natura».
Non mancano delle proposte di «rivedere le formule cristologiche» per i cristiani che vivono in un contesto culturale buddista. Per es. il gesuita singalese A. Pieris5 insiste soprattutto sulla lotta per essere povero e la lotta a favore del povero.
Noi citiamo alcuni passaggi dal grosso saggio di H. Küng sulle religioni6.
Il primo testo è la ripresa di una considerazione, molto audace per vero, ma suggestiva, di un teologo americano.
«Quello che ha da dire il teologo americano John Cobb ... dovrebbe far riflettere: “Il buddismo shin non ha ancora affrontato la crisi del rapporto tra storia e fede. Se esso si confronta con questa crisi, i suoi problemi si presentano, sotto parecchi aspetti, più pressanti di quelli di fronte ai quali si è trovato il cristianesimo; la sua base è infatti ancora più lontana dal corso reale della storia. Esso può certamente trovare molti appoggi nel Budda e nella storia del buddismo, ma là dove la sua dottrina è più caratteristica esso trova un appoggio minimo in questa tradizione, che precede lo stesso Shinran».
Poi Cobb compie: un grande passo, che certamente solo pochi buddisti sono disposti a imitare:
«Tuttavia, niente nell’autocomprensione buddista presuppone la necessaria ammissione che la storia cercata possa venir trovata soltanto in India o nell’Asia orientale. Al contrario, il buddismo tende all’universalità. Pure esso richiede una visione inclusiva di tutte le cose,e oggi una tale visione deve abbracciare la storia universale. Ma la storia universale comprende anche la storia di Israele e l’evento Gesù. Quella storia che comprende la visione cristiana della benevolenza di Dio, sostiene anche la concezione, propria del buddismo shin, della sapienza e della compassione, che caratterizzano la realtà ultima... Appena questo atteggiamento [di sospetto e di difesa] venga superato realmente, non esiste più un motivo di principio perché i buddisti non possano accogliere anche il passato palestinese, come hanno accolto quello indiano. E’ più in Palestina che in India che la storia, quando venga letta come incentrata in Gesù, offre la base più solida per la fede, e che noi veniamo redenti dalla grazia ia virtù della fede».
Ed ancora:
«Quando impara a conoscere la figura del Budda, che fu un uomo che pensava in maniera elitaria, il cristiano avvertirà la grande sfida a mettere radicalmente in questione e a ristrutturare la propria vita orientata forse troppo sul successo e sull’attivismo. Viceversa, quando il buddista accetta di confrontarsi con Gesù di Nazaret, con il Cristo, che aveva compassione del popolo e accoglieva i falliti, percepirà un invito a superare “per il bene di tutti gli uomini” la divisione in due classi dei credenti, a dare al laico, ritenuto inferiore, non soltanto una funzione di secondo grado, ma anche un accesso diretto alla liberazione, un diritto e una dignità propri, a venire in aiuto dei deboli, degli sfortunati e degli sfruttati, per trasformare proprio in questo modo il mondo qui e ora, nella compassione e nell’amore, per il bene di tutti».
Note
(4) Cf. lo studio di P. NGUYEN VAN T0T, Le Bouddha etle Christ, Urbaniana Press, Roma 1987.(5) A. PIERIS, Buddismo: sfida ai cristiani, in «Concilium», 22(1986), pp. 97s. Per un’analisi più ampia:: rimandiamo ad un importante numero di «Concilium», 14(1978) 6: Buddismo e cristianesimo.
6) H. KÜNG, Cristianesimo e religioni universali, Mondadori, Milano 1986, pp. 513s e 424. Nella prima citazione egli si riferisce allopera di. COBB, Beyond Dialogue. Toward a Mutual Transformation of Chrislianity and Buddhism, 1982, pp. 139-140.
INDUISMO
Qui il rapporto è invece molto più complesso e anche la letteratura è abbondante. C’è un fatto molto interessante: l’affermazione frequente di molti convertiti dall’ induismo al cristianesimo, e anche di molti cristiani profondamente «induizzati», i quali dicono che il Vangelo non sarà mai compreso appieno sinché esso non riceverà anche l’interpretazione «induista». Questo lo si dice specialmente al riguardo del Vangelo di Giovanni: «I cristiani non riusciranno a capire il Vangelo di san Giovanni se non quando l’India sarà cristiana». In generale possiamo dire che:
— Gesù Cristo si innesta bene nella religione bhakti, un ramo non secondario dell’induismo, praticamente tutta la religione del popolo indù. Il motivo di fondo è che la religione bhakti si basa su un dialogo d’amore tra il fedele e il suo Dio (o Krisna o Visnu o Siva), in maniera non dissimile da quello che può avvenire per il cristianesimo per un cristiano «medio».
— Gesù Cristo - trasportato nella visione indù - avrebbe così una funzione simile a quella di Krisna e sarebbe visto come un’avatara di Visnu. La Bhagavad-gita e alcuni Purâna sono essenzialmente i testi della bhakti a cui si ispira una simile visione.
I primi tentativi consapevoli di collaborazione tra cristianesimo e induismo risalgono all’opera missionaria di Roberto de Nobili (1577-1656), esempio di un’autentica inculturazione: si fece brahmino, imparò le lingue sanscrito e tamil, accettò le caste e l’intoccabilità. Altro pioniere è stato Bartolomeo Ziegenbalg (1683-1719), tedesco luterano.
Ma soprattutto importante va ritenuto il ruolo del rinascimento indù del XIX secolo. Esso raggiunse l’apice nel «Brahmo Samaj» fondato da Raja Ram Mohan Roy (1830). Si volle rinnovare l’induismo nel senso di un monoteismo ispirato ai Vedanta e al discorso della montagna, con chiari obiettivi umanistici.
Altre figure che emergono: Keshab Chander Sen (Cristo è un «orientale», logos della nuova creazione); Ramakrishna (1836-1886) (e il suo discepolo continuatore del movimento: Vivekananda), estatico grandissimo, ebbe anche una visione di Cristo. Considerò Gesù come un orientale, dei più grandi maestri di tutti i tempi, a ragione chiamato Dio. Gli europei lo avrebbero interpretato male e abusivamente trasformato in un testimone di una storia missionaria imperialista; è invece maestro dell’interiorità e dei senza patria.
Altri nomi da ricordare: Mahatma Gandhi: per lui Cristo non è un monopolio del cristianesimo, ma un modello per tutti gli uomini, specie in alcuni principi: come la forza della verità, la non violenza, il servizio al prossimo. Vinobba (discepolo di Gandhi): Gesù fu il più grande dei satyagrahi: cioè di coloro che credono nella forza della verità e si impegnano per essa.
Da parte cristiana va notata l’esperienza di «inculturazione» (attraverso gli Ashrams cristiani) di J. Monchanin (+1957), H. Le Saux (Swami Abhishiktananda + 1973; che nel 1968 si ritirò sull’Himalaya a fare l’eremita), Bede Griffiths (autore del libro noto: Ritorno al centro).
Una menzione particolare anche per R. Panikkar, nel suo libro noto, Il Cristo sconosciuto dell'Induismo7: egli sviluppa un notevole parallelismo tra Cristo e Isvara (creatore, signore e manifestazione suprema di Brahman).
Interessante anche il caso del Giappone: dove si riscontrano sia condizioni culturali favorevoli al messaggio cristiano, sia un profondo e quasi «insuperabile» sentimento di rifiuto della visione cristiana.
Note
(7) Vita e Pensiero, Milano 1976.

NEO-MARXISMO
Non è curiosità inutile rivolgere uno sguardo anche nel campo marxista e ascoltare cosa hanno da dire su Gesù Cristo coloro che credono nella visione marxista della storia e dei progetti: è una visione materialistica e atea per principio. Ma vi sono anche a volte interessi culturali per la figura di Cristo che possono dire qualcosa.
Vi sono sì - e ancora tantissimi - marxisti che negano storicità alla figura storica di Gesù, lavorando a smontare la credibilità dei testi e delle fonti. In questo più che Engels e Bauer, maestro indiscusso e caposcuola classico è Karl Kautsky, con l’opera Der Ursprung des Christentums, Kautsky spiega l’insorgere, il chiarificarsi e la definitiva fisionomia del cristianesimo non come derivante da Cristo (che non si sa se è esistito), ma da cause storiche; oppressioni, schiavitù, ribellione. Gesù è per lui un «ribelle», che ha tentato un colpo di stato; nell’orto degli olivi il gruppo (che era armato) era pronto al colpo di mano, da una posizione strategicamente importante. Ma la cosa fallì, anche per il tradimento di Giuda. Il Vangelo è «storicizzazione» di speranze rivoluzionarie che di fatto non si realizzarono. Subentrò invece l’istituzione, che a sua volta divenne potenza e oppressione. «Non fu la fede nella risurrezione del Crocifisso che ha creato la comunità e gli ha dato vigore; ma, al contrario, la vitalità della comunità creò la fede nella sopravvivenza del suo Messia»8.
Ci sono altri studiosi (non russi) che accettano la storicità (sostanziale) delle testimonianze, e vogliono trovare in Gesù un insegnamento che non sia monopolio del solo cristianesimo.9 Questi sono soprattutto coloro che sono chiamati neo-marxisti; da catalogare più come filosofi che critici storici. Fra questi vogliamo ricordarne alcuni.
E. Bloch (1885-1977); autore dell’opera in tre volumi Das Prinzip Hoffnung10. L’idea da tener presente è che, per Bloch, l’uomo è connotato dalla categoria del poter-essere, dalla continua tensione verso ili futuro. «Homo absconditus» è il titolo che egli usa; significa identità non ancora svelata (quindi in cammino, nomade), da inventare in un qualcosa non ancora realizzato. Nella religione, specie quella ebraico-cristiana egli scopre (come tanti altri marxisti) anche un’alienazione; ma soprattutto una tensione verso il futuro, il «regno», verso un avvenire migliore.
Gesù per Bloch non pare relegabile al dolce rabbi nazareno: egli è piuttosto un ribelle, colui che si mette contro ogni forma di schiavitù, pagando anche il prezzo di questa ribellione; che è la croce. La croce non è - come per i cristiani - «gesto supremo d’amore e di fedeltà» al Padre, ma viene dal di dentro dei conflitti: come ultimo segno di una ribellione allo statu quo che non può essere sopportato, ma che bisogna pagare con l’eliminazione fisica. Con plastiche immagini Bloch parla di Gesù come eschaton, come speranza mai domata, come Prometeo che ruba il fuoco agli dèi (e viene inchiodato sulla roccia), a favore dei poveri, o come «serpente» che invita «eritis sicut deus».
V. Gardavsky (cecoslovacco). Anch’egli sviluppa il concetto di Gesù come modello aperto di umanità e ricorre alla concezione veterotestamentaria dell’uomo come essere storico aperto, soggetto di azione creatrice, come Giacobbe incapace di sopportare il ruolo di secondogenito, e «lottatore» perfino contro Dio per strappargli la benedizione. Così appare come la massima incarnazione dell’ideale di un uomo dalle infinite possibilità, in continua esperienza di autotrascendimento. La sua riflessione è legata al momento politico della Cecoslovacchia del 1968
R. Garaudy (francese), filosofo marxista dissidente, oggi passato all’islam. Egli si muove sempre sulla linea dell’autotrascendimento. Per lui l’uomo ha per qualità primaria la capacità di autotrascendenza, la capacità di rompere il cerchio dell’ordine costituito, egli è libertà, progetto, creatività continua. Questa qualità/situazione di fondo è anche un’impresa da compiere: e questo lo porta a superare anche le strutture del socialismo storico. In Gesù si ritrova questa verità di un Dio che non si rassegna, ma con amore rischia, andando incontro al superamento continuo di ogni schema rigido. Nel suo morire e risorgere egli è appello al superamento di ogni limite, anche della morte, come annuncio che tutto è possibile. Ogni nostra azione rivoluzionaria e nuova rende vivente tra noi lui, Gesù di Nazaret.
Ha scritto in un saggio:
«Ogni qualvolta riusciamo a romperla con il nostro vivere di routine, con la nostra tendenza alla rassegnazione, con la nostra facilità a cedere, con le nostre alienazioni nei confronti dell’ordine costituito o della nostra meschina individualità, e grazie a tale rottura, riusciamo a compiere un atto creativo sia in campo artistico o scientifico; sia nell’azione rivoluzionaria o nell’amore: ogni qualvolta contribuiamo con qualcosa di nuovo alla realizzazione della vita umana il Cristo è vivente in noi; da noi e tramite noi si continua la creazione. La risurrezione si compie ogni giorno».
M. Machovec (cecoslovacco): ricordiamo di lui l’opera Gesù per gli atei. Egli parla con grande simpatia di Gesù, anche se utilizza le categorie teologiche post-bultmanniane (dalla cristologia diretta a quella indiretta), ma mette in dubbio un gran numero di dati evangelici. Egli legge la vicenda Gesù con un’ottica «marxista» attenta ai rapporti fra classi sociali.
Senza dubbio appare affascinato dalla personalità di Gesù, e ne sottolinea il tema della povertà-ricchezza che si associa strettamente anche con l’esaltazione dell’infanzia, come situazione non alienata, tempo di libertà e mitezza; amore-non violenza: un amore radicale che raggiunge una profondità straordinaria, come appare dal precetto dell’amore anche verso il nemico; lotta al fariseismo.
L. Kolakovski (polacco), fra l’altro autore di Senso e non senso della tradizione Cristiana. Presenta Gesù come un «profeta e un riformatore». Egli dice di muoversi da un punto di vista puramente filosofico, come laico, fuori delle chiese, attento al posto di Gesù nella cultura europea in generale (cita ad es. Pascal, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, ecc.). Individua nell’insegnamento di Gesù «cinque nuove regole»: abolizione della legge a favore dell’amore; non violenza. nei rapporti umani; non di solo pane vive l’uomo (cioè ci sono anche altri valori); abolizione dell’idea di popolo eletto (cioè Dio ora è accessibile a tutti); precarietà dell’esistenza umana.
Osservazioni. Per riuscire a capire l’interesse dei «neo-marxisti» per la figura storica di Gesù Cristo, non si deve dimenticare che essi si sono trovati di fronte alla crisi di «ispirazione» del marxismo, e al bisogno di riscoprire il soggetto, il senso della vita, la dimensione «trascendente» dell’uomo. Per questo il messaggio etico di Gesù, specie l’enfasi sull’amore, sull’uguaglianza, sul valore della persona, sulla resistenza al male fino a morire, li attrae e sembra loro un modello di «correzione» anche per il marxismo. Horkheimer direbbe che si tratta della «nostalgia del totalmente Altro», come nostalgia «di perfetta e consumata giustizia».
Di recente anche altri valori vengono presi in seria considerazione, come la pietà, il perdono, la misericordia, il peccato, l’amore, Lo ha dimostrato il simposio di Budapest (8-10 settembre 1986) su «Società e valori etici», organizzato dal Segretariato vaticano per i non credenti e dall’Accademia ungherese per le scienze.
Possiamo dire che queste considerazioni proposte dai neo- marxisti hanno un certo interesse e senz’altro hanno influito sulla cultura e sulla stessa teologia in tempi recenti.
Tirando un po’ di conclusioni, possiamo dire che la linea neomarxista, sommata ad altri elementi filosofici, psicologici, culturali, e anche a specifici impulsi «teologici» - come quello di Bonhoeffer: Gesù come «uomo per gli altri» - ha trovato accoglienza e sviluppo (in termini più specificamente cristiani) in non poche riflessioni dei teologi attuali. Citiamo per tutte la «teologia della speranza», esplicitamente ispirata a Bloch, per attestazione dello stesso Moltmann.
Echi e analogie si ritrovano anche nella teologia politica, nella teologia della rivoluzione, in alcuni testi della teologia della liberazione (non i più noti). In particolare per quanto riguarda la comune preoccupazione di delineare una fisionomia di Gesù ricca di sovversività, vittima dei giochi e degli interessi dei potenti, simbolo di tutti gli oppressi della storia, ribelle che vuole e vive una prassi diversa, uomo che muore-risorge come supremo testimone dell’alterità, e la cui memoria rimane pericolosa e sovversiva. Di tutto questo avremo modo più avanti di offrire indicazioni maggiormente puntuali.
L’enfasi su Gesù «uomo libero e aperto» ha contagiato, per osmosi culturale, anche il linguaggio catechetico, gli schemi omiletici, perfino molti testi di meditazione. E questo è un interessante apporto della cultura attuale alla spiritualità cristiana. Ma dobbiamo fare attenzione a conservare completa la verità su Gesù Cristo e non ridurla solo ad alcuni, interessanti, stimoli prassiologici o antropologici.
Il dialogo interreligioso ha infine condotto a rileggere la verità che sta prima e oltre la formulazione «dogmatica» dei concili, per sceverare gli elementi ancora non «fissati» in formule, eppure preziosi e vitali. Perché anche a tutti i popoli e alle tradizioni sia concesso di «vedere Gesù» (cf. Gv 12,21) ed essere accolti da lui con il «giubilo nello Spirito», e così possano guardare a colui che, «innalzato da terra, attira tutti a sé» (cf. Gv 12,32), e credendo alla luce «diventare figli della luce» (Gv 12,36).
Il Cristo è destinato «a ricapitolare tutte le cose» (Ef 1,10), perché le ha riscattate col suo sangue sulla croce; ma anche perché tutto è stato «eletto in lui fin dalla fondazione del mondo» (Ef 1,4) e tutto esiste «in vista di lui» (Col 1,16s). Con l’incarnazione il Verbo ricapitola in sé, in modo visibile, il primato sul cosmo intero, che gli apparteneva in modo invisibile.
Le ricerche e i «cammini» delle religioni abramitiche, come le «vie» e i «sentieri» delle grandi religioni asiatiche o delle tradizioni a sfondo cosmico o animista, ci hanno fatto vedere quanto siano numerosi e preziosi i «semi del Verbo» e i segni di santità, e quanto numerosi siano coloro «che lo cercano con cuore sincero».
Di tutto questo Cristo è artefice e pienezza, spiegazione e fondamento, misteriosa presenza e talora anche figura deformata; rimane implicito soprattutto redentore e signore. Alla nostra epoca tocca «assecondare» gli impulsi dello Spirito, mediante il dialogo rispettoso e sincero, e condurre alla piena realizzazione questa signoria universale di Cristo (cf. GS 92).
Note
(8) KAUTSKY, Der Ursprung, p. 400
(9) Per una migliore e diretta conoscenza cf.: J.M. LOCHMAN, Gesù o Prometeo?, Cittadella, Assisi 1975; T. PRÖPPER, Jésus: raison et foui, Desclée, Paris 1978; I.FETSCHER-M. MACHOVEC, Marxisti di fronte a Gesù, Queriniana, Brescia 1976.
(10) Sono tre volumi editi a Berlino (est) negli anni 1954-1959. Tenere presenti anche Ateismo nel cristianesimo, Feltrinelli, Milano 1971 e Religione in eredità, Queriniana. Brescia 1979.
L'assist (Evgenij Nikolaevic Trubeckoj)
L’antica iconografia russa utilizza in modo simbolico tutte queste tinte. I pittori sapevano disporle giustamente per differenziare il cielo trascendente da quello terrestre che domina la nostra esistenza. Qui si trova la chiave che apre la comprensione della bellezza ineffabile del simbolismo pittorico dei colori.
Giustizia e Carità. Affrontare le sfide del futuro: i rapporti ebraico-cattolici nel 21° secolo. Dichiarazione congiunta (Comitato Internazionale di Raccordo tra Cattolici ed Ebrei)
Giustizia e Carità. Affrontare le sfide del futuro:
i rapporti ebraico-cattolici nel 21° secolo
Dichiarazione congiunta
18a Riunione del Comitato Internazionale di Raccordo tra Cattolici ed Ebrei

Buenos Aires 5-8 luglio 2004. Incontro dell’ International Catholic-Jewish Liaison Committee (ILC) sul tema: “Giustizia e Carità. Affrontare le sfide del futuro: i rapporti ebraico-cattolici nel 21° secolo”.
I rapporti tra la Chiesa cattolica ed il popolo ebraico hanno sperimentato grandi cambiamenti dalla Dichiarazione del Concilio Vaticano II Nostra Aetate (1965), che ha sottolineato le radici ebraiche del Cristianesimo e il ricco patrimonio spirituale condiviso da Ebrei e Cristiani. Nell’ultimo quarto di secolo, il Papa Giovanni Paolo II ha approfittato di tutte le occasioni che si sono presentate per promuovere il dialogo tra le due comunità di fede, che considera inerente alle nostre identità. Questo dialogo ha generato un’intesa e un rispetto reciproci. Speriamo di continuare ad arrivare a circoli sempre più ampi e di toccare le menti ed i cuori di Cattolici ed Ebrei e dell’intera comunità.
La 18ª Riunione del Comitato internazionale di raccordo tra Cattolici ed Ebrei ha avuto luogo a Buenos Aires dal 5 all’8 luglio 2004. Questo incontro, celebrato per la prima volta in America Latina, ha avuto come tema centrale Tzedek and Tzedakah (Giustizia e Carità) nei loro aspetti teorici e nelle loro applicazioni pratiche. Le nostre decisioni sono state ispirate dal comandamento divino “Amerai il prossimo tuo come te stesso” (Lev 19,18; Mt 22,39). Dalle nostre diverse prospettive, abbiamo rinnovato il nostro impegno nei confronti della difesa e della promozione della dignità umana in base all’affermazione biblica per la quale ogni essere umano è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio (Gen 1,26). Ricordiamo la difesa dei diritti umani di Papa Giovanni XXIII per tutti i figli di Dio enunciata nella sua enciclica Pacem in Terris (1963) e le rendiamo un tributo speciale per aver iniziato questo scambio fondamentale nei rapporti ebraico-cattolici.
Il nostro impegno reciproco nei confronti della giustizia ha una profonda radice in entrambi i Credo religiosi. Ricordiamo la tradizione di aiutare la vedova, l’orfano, il povero e lo straniero derivanti dal comandamento di Dio (Es 22,20-22; Mt 25,31-46). I Maestri di Israele hanno sviluppato un’ampia dottrina di giustizia e carità per tutti, basata su una profonda comprensione del concetto di Tzedek. Costruendo sulla tradizione della Chiesa, il Papa Giovanni Paolo II, nella sua prima enciclica, Redemptor Hominis (1979), ricordava ai Cristiani che un vero rapporto con Dio richiede un forte impegno nel servizio nei confronti del nostro prossimo.
Anche se Dio ha creato l’essere umano nella diversità, lo ha dotato della stessa dignità. Condividiamo la convinzione per cui ogni persona ha diritto ad essere trattata con giustizia ed equità. Questo diritto include il fatto di condividere la grazia e i doni di Dio (hesed).
Vista la diffusione della povertà, dell’ingiustizia e della discriminazione, abbiamo il dovere religioso di preoccuparci per i poveri e per coloro che sono stati privati dei propri diritti politici, sociali e culturali. Gesù, radicandosi profondamente nella tradizione ebraica dei suoi tempi, ha fatto dell’impegno nei confronti dei poveri una priorità del Suo ministero. Il Talmud afferma che il Santo, sia Benedetto, ha sempre cura dei bisognosi. Attualmente questa preoccupazione deve comprendere ampi gruppi in tutti i continenti: gli affamati, gli orfani, le vittime dell’AIDS, tutti coloro che non ricevono cure mediche adeguate e quelli che non sperano in un futuro migliore. Nella tradizione ebraica, la forma superiore di carità consiste nell’abbattere le barriere che impediscono ai poveri di uscire dalla loro condizione di povertà. Negli ultimi anni la Chiesa ha sottolineato la propria scelta preferenziale per i poveri. Gli Ebrei e i Cristiani hanno lo stesso dovere di lavorare per la giustizia con carità (Tzedakah), arrivando così alla pace (Shalom) per tutta l’umanità. Fedeli alle nostre rispettive tradizioni religiose, vediamo questo impegno comune nei confronti della giustizia e della carità come la cooperazione dell’uomo con il piano divino per costruire un mondo migliore.
Alla luce di questo impegno comune, riconosciamo la necessità di trovare una soluzione per queste grandi sfide: la crescente disparità economica tra i popoli, la grande devastazione ecologica, gli aspetti negativi della globalizzazione e il bisogno urgente di lavorare per la pace e la riconciliazione.
Sono quindi benvenute le iniziative congiunte delle organizzazioni internazionali cattoliche ed ebraiche che hanno iniziato a lavorare per risolvere i problemi dei poveri, degli affamati e degli ammalati, dei giovani, di coloro che non hanno accesso all’educazione e degli anziani. Sulla base di queste azioni di giustizia sociale ci vogliamo impegnare a raddoppiare i nostri sforzi per soddisfare i bisogni più pressanti di tutti attraverso il nostro impegno comune nei confronti della giustizia e della carità.
Man mano che ci avviciniamo al 40° anniversario della Nostra Aetate, la dichiarazione del Concilio Vaticano II che ha ripudiato l’accusa di deicidio contro gli Ebrei, ha riaffermato le radici ebraiche del Cristianesimo e ha condannato l’antisemitismo, prendiamo nota dei molti cambiamenti positivi che la Chiesa cattolica ha operato nei suoi rapporti con il popolo ebraico. Questi ultimi 40 anni di dialogo fraterno contrastano in maniera sostanziale con quasi duemila anni di “insegnamento del disprezzo”, con tutte le sue dolorose conseguenze. Prendiamo energia dai frutti degli sforzi collettivi, che includono il riconoscimento del rapporto unico e continuo tra Dio e il popolo ebraico e il rifiuto totale dell’antisemitismo in tutte le sue manifestazioni, incluso l’antisionismo come espressione più recente dell’antisemitismo.
Da parte sua, la comunità ebraica ha evidenziato un desiderio crescente di portare a termine un dialogo interreligioso ed azioni congiunte su questioni religiose, sociali e comunitarie a livello locale, nazionale e internazionale, come illustra il nuovo dialogo diretto tra il Gran Rabbinato di Israele e la Santa Sede. La comunità ebraica, inoltre, ha compiuto numerosi passi a livello di programmi educativi sul Cristianesimo, sull’eliminazione dei pregiudizi e sull’importanza del dialogo ebraico-cristiano. La comunità ebraica ha poi preso coscienza, deplorandolo, del fenomeno dell’anticattolicesimo in tutte le forme in cui si manifesta nella società.
Nel 60° anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti, dichiariamo la nostra decisione di impedire la rinascita dell’antisemitismo che ha condotto al genocidio e alla Shoah. Su questo punto siamo uniti e seguiamo gli indirizzi delle principali conferenze internazionali su questo problema che sono state realizzate recentemente a Berlino e presso le Nazioni Unite a New York. Ricordiamo le parole del Papa Giovanni Paolo II, che ha affermato che l’antisemitismo è un peccato contro Dio e contro l’umanità.