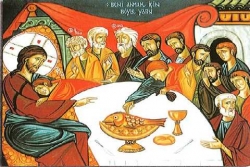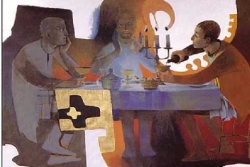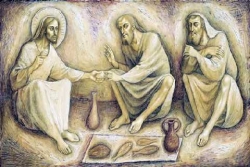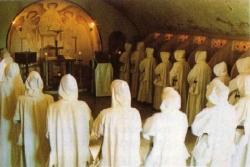In libreria
Visualizza articoli per tag: Liturgia, culto, rito
L’altare: cuore e centro della celebrazione (Rinaldi Falsini)
L’altare: cuore e centro della celebrazione
di Rinaldi Falsini

La riforma liturgica ha evidenziato la centralità dell’altare: in esso si rende presente il sacrificio della Croce ed è anche la mensa del Signore.
La discussione sull’altare verso il popolo (VP 10/2006, pp. 54-55) ha concentrato tutto l’interesse, mettendo in ombra le altre caratteristiche non meno importanti che la riforma liturgica ha riconosciuto all’altare cuore e centro della celebrazione liturgica. Si spiega pertanto la difficoltà di un’intesa su un aspetto che, nonostante la sua innegabile risonanza pastorale e culturale, appare secondario e meno ovvio nel complesso della sua natura e funzione. La soluzione di questo e altri problemi risiede primariamente nel prendere atto della posizione dell’altare alla luce delle recenti disposizioni che - possiamo aggiungere tra parentesi - si fondano anche sulla conoscenza dell’origine e dello sviluppo storico che qui non possiamo ricercare.
Il documento di riferimento è l’Ordinamento generale del Messale Romano (3ª ed., 2000, Ogmr), senza dimenticare per l’Italia L ‘adeguamento delle chiese alla riforma liturgica, 1996; mentre tra le trattazioni specifiche ricordiamo due numeri della Rivista di pastorale liturgica (158/1990 e 202/1997) e il magistrale studio L’altare mistero di presenza, opera dell’arte, a cura di G Boselli (Monastero di Bose, 2005).
Tralasciando le questioni storiche, scegliamo quegli aspetti messi in maggiore evidenza dalla riforma liturgica. Anzitutto partiamo da una premessa dottrinale, su ciò che avviene sull’altare come realtà oggettiva citando questa chiara affermazione dell’Ordinamento generale 296: «L’altare sul quale si rende presente nei segni sacramentali il sacrificio della Croce è anche la mensa del Signore, alla quale il popolo di Dio è chiamato a partecipare quando è convocato per la messa; l’altare è il centro dell’azione di grazie che si compie con l’eucaristia».
Sacrificio e banchetto eucaristico sono strettamente congiunti proprio in base alla comune mensa eucaristica ove si attualizza il sacrificio nei segni sacramentali di pane e vino e alla quale i fedeli sono convocati a partecipare comunicandosi al corpo e al sangue di Cristo: due aspetti fondamentali che emergono dalla centralità dell’azione eucaristica compiuta su quella mensa. Il tutto in un clima di azione di grazie e di festa, con l’accenno ai fedeli e ai segni di pane e vino.
Ecco una presentazione completa e originale del mistero eucaristico che si realizza sull’altare capace di superare ogni divisione e contrasto a cominciare da quanti hanno creduto che la celebrazione eucaristica sull’altare verso il popolo possa oscurare l’aspetto sacrificale, tutto a favore dell’aspetto conviviale. Un’idea priva di ogni fondamento, avanzata fin dal 1993 e riproposta di recente in un’intervista a un giornale italiano da Uwe M. Lang, autore del noto saggio Rivolti al Signore. L’affermazione dell’Ordinamento generale 296 merita di essere sottolineata anche nella stessa catechesi eucaristica a vantaggio del significato della comunione eucaristica ridotta a un semplice incontro con Gesù, trascurando ogni raccordo con il suo sacrificio della croce.
Il nuovo volto o meglio la figura rinnovata dell’altare è tratteggiata dal numero 299, completato da altri particolari del relativo paragrafo: «L’altare sia costruito staccato dalla parete, per potervi facilmente girare intorno e celebrare rivolti verso il popolo: la qual cosa è conveniente realizzare ovunque sia possibile. L’altare sia poi collocato in modo da costituire realmente il centro verso il quale spontaneamente converga l’attenzione dei fedeli. Normalmente sia fisso e dedicato».
Il testo, proveniente dall’istruzione Inter oecumenici (26.9.1964), elaborato quindi dalla Commissione preparatoria, viene ritenuto determinante per ridonare all’altare la sua “personalità” e la “centralità” dell’assemblea celebrante. Il distacco dalla parete è previsto per il rito della dedicazione da parte del vescovo e l’incensazione nella messa cantata o solenne.
Ma è la dignità dell’altare che richiede il distacco dalla parete per acquisire una propria autonomia. Mentre la sua posizione di centro ideale nell’assemblea, in modo da attirare l’attenzione “spontanea”, tende ad avvicinare clero e fedeli, favorendo la partecipazione, soprattutto per il valore simbolico di Cristo che gli viene attribuito dalla tradizione e dalla stessa dedicazione. Occorrerà non solo la vicinanza dei fedeli all’altare (il Canone romano parla di circumstantium), ma anche la scelta di una posizione visibile, alquanto elevata, ben illuminata.
Attorno all’altare ci sarà uno spazio aperto perché si possa celebrare rivolti al popolo e suscitare un clima familiare. Chi entra in chiesa deve sentirsi come chi entra nella propria casa: la tavola è la realtà che diventa centro e crea famiglia,consolidando i rapporti, senza per questo perdere sacralità, rispetto, venerazione, segno di Cristo e luogo in cui si compiono i misteri di salvezza. Il sacralismo preconciliare aveva creato la balaustra con la relativa comunione in bocca, ma la partecipazione dei fedeli alla mensa eucaristica non deve incontrare barriere di sorta pur nella consapevolezza del suo significato di fede.
È interessante l’accenno alla celebrazione rivolti al popolo, chiara e decisa, quasi ovvia, in una ritrovata unità e nel rapporto dialogico proprio della lingua parlata. Tutto è coerente e ordinato, anche se le modalità operative non sono sempre facili e soddisfacenti.
Il numero prosegue con il richiamo all’altare “fisso” e non mobile, trattandosi di una chiesa, con la mensa di pietra, come dispone l’Ordinamento generale 301, «secondo un uso e un simbolismo tradizionali nella Chiesa». Gli antichi altari sono di legno e hanno la forma di tavolo (mensa-trapeza) piccolo, a forma di ferro di cavallo; ma fin dal secolo IV era già comune l’altare di pietra soprattutto per influsso biblico, come metafora di Cristo, «la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d’angolo» (cf Mt 21,42; 1Pt 2,4). Con questo passaggio si rafforza il significato cristologico arricchito dall’unzione nel rito della dedicazione, nel quale è detto che «con l’unzione del crisma l’altare diventa simbolo di Cristo». Così l’altare diventa simbolo di Cristo unico sacerdote, altare e vittima (come si legge nel prefazio pasquale V), assumendo in seguito una forma quadrangolare per indicare che esso è centro del mondo e poi della Chiesa.
L’altare - conclude il numero 299 - deve essere non soltanto fisso ma “dedicato”, mentre per quello mobile è sufficiente la benedizione. Non è questo il momento dell’analisi del rito della dedicazione, anche se la ricchezza simbolica evocata non può passare sotto silenzio. Ci limitiamo a segnalare lo studio di Paul De Clerck (nel volume citato. L’altare mistero di presenza, opera dell’arte, pp. 39-51) e il prefazio della dedicazione dell’altare: «Sacerdote e vittima della nuova alleanza / egli comandò di perpetuare nei secoli / il sacrificio a Te offerto sull’altare della croce. / Ti dedichiamo con gioia questa mensa / dove (…) ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio / per formare la tua Chiesa una e santa. / Alle sorgenti di Cristo, pietra spirituale, / attingiamo il dono del tuo Spirito / per essere anche noi / altare santo e offerta viva a te gradita».
Sulla suppellettile dell’altare rinviamo ai numeri rispettivi: si distenda sopra l’altare sul quale si celebra una tovaglia di colore bianco (cf Ogmr 304); i candelieri siano posti sopra o accanto all’altare (cf 307); la croce ben visibile sia ugualmente posta sopra l’altare ovvero a fianco (cf 308).
Un problema delicato, relativo all’unicità dell’altare nelle chiese già costruite e in quelle nuove, è affrontato con chiarezza al numero 303: «Nelle nuove chiese si costruisca un solo altare»; nelle vecchie «si costruisca un altro altare fisso» e il vecchio altare sia privo di ogni ornamento. Viene indicata come motivazione che un solo altare significa «alle comunità l’unico Cristo e l’unica eucaristia della Chiesa».
Aggiungiamo tra le “Precisazioni” della Chiesa italiana inserite nel Messale, il n. 14, che riassume alcune questioni aperte e ne offre la soluzione: «L’altare fisso della celebrazione sia unico e rivolto al popolo. Nel caso di difficili soluzioni artistiche per l’adattamento di particolari chiese e presbiteri, si studi, sempre d’intesa con le competenti commissioni diocesane, l’opportunità di un altare mobile appositamente progettato e definitivo. Se l’altare retrostante non può essere rimosso o adattato, non si copra la sua mensa con la tovaglia. Si faccia attenzione a non ridurre l’altare a un supporto di oggetti che nulla hanno a che fare con la liturgia eucaristica.
«Anche i candelieri e i fiori siano sobri per numero e dimensione. Il microfono per la dimensione e la collocazione non sia tanto ingombrante da sminuire il valore delle suppellettili sacre e dei segni liturgici».
su un gesto piccolo ma carico di un grande valore significativo, che il presidente di ogni celebrazione eucaristica compie, anche a nome di quanti rappresenta, all’inizio e al termine dell’azione: il bacio dell’altare.Dal n. 49: «Giunti in presbiterio il sacerdote e il diacono e i ministri salutano l’altare con un profondo inchino. Quindi, in segno di venerazione, il sacerdote e il diacono lo baciano e il sacerdote, secondo l’opportunità incensa la croce e l’altare». Dal n. 90: l’ultimo rito di conclusione comprende «il bacio dell’altare da parte del sacerdote e del diacono e poi l’inchino profondo all’altare da parte del sacerdote, del diacono e degli altri ministri».
Attraverso il simbolo, il bacio va alla persona medesima di Cristo, ha scritto il compianto amico L. Della Torre: baciare una persona non è senza una profonda relazione con lui e senza coinvolgimento nei suoi riguardi. Poiché Cristo simboleggiato dall’altare, è il capo, il bacio è a lui dato per estensione a tutto il suo corpo.
(da Vita Pastorale, Novembre 2006)
Perché la riforma voli sempre più in alto (Silvano M. Maggiani osm)
Perché la riforma voli sempre più in alto
di Silvano M. Maggiani osm *
La prima settimana prese avvio nel 1957. Ne furono celebrate tredici, con una buona partecipazione di insegnanti ogni volta. Nel XII corso, a Ferrara di Monte Baldo (Vr), 1979, si maturò la consapevolezza di dover dare vita a una vera e propria Associazione dei docenti e cultori di liturgia. Nel clima associazionistico del tempo erano già nate le associazioni dei teologi, dei moralisti e degli storici della Chiesa. Ma soprattutto stava prendendo sempre più consistenza il dover rispondere al dettato della costituzione liturgica che prescriveva di computare la liturgia nei seminari e negli studentati religiosi, “tra le materie necessarie e più importanti” e nelle facoltà teologiche “tra le materie principali” (SC 16).
Per rispondere a questa istanza, da una parte, il dettato conciliare richiedeva per i professori di liturgia di “ricevere una speciale formazione” per tale compito in istituti a ciò destinati (SC 15) e, dall’altra, ci si rendeva conto che l’andare oltre una conoscenza rubricistica a favore di uno studio della teologia liturgica e dell’approfondimento di che cosa si celebra e come si celebra, sollecitata dai primi frutti della riforma liturgica, comportava un investimento di persone e di tempi che non potevano essere circoscritti a iniziative solitarie o meramente autonome. Lo statuto proprio del celebrare e per mezzo dei segni sensibili, per mezzo dei riti e delle preghiere il mistero del Signore Gesù, in Spirito Santo, esige una intelligenza per la sua comprensione e per la sua messa in atto che coinvolge necessariamente più competenze a confronto tra loro.
Così nel XIII corso organizzato dal CAL a Bergamo (1972) al termine della Settimana liturgica nazionale, il giorno 8 settembre fu costituita ufficialmente l’associazione, autonoma dallo stesso CAL, il quale perseguiva strade più pertinenti all’alta divulgazione e alle immediate scelte pastorali. L’associazione fu voluta aperta «a coloro che svolgono ricerche in discipline liturgiche o complementari, oppure sono incaricati per la liturgia nelle diocesi o negli istituti religiosi» (Statuti, art. 4).
Dal 1972 a oggi l’Apl ha organizzato 34 settimane di studio, di cui sono stati pubblicati gli Atti (quelli della 34ª Settimana saranno editati nel 2007). Essi sono i risultati più significativi e concreti della cura che i soci, tramite le assemblee annuali e i vari consigli di presidenza, hanno impiegato per attuare e rispondere allo scopo precisato negli Statuti, art. 2.
Esso è unico, ma dinamicamente vuole coinvolgere l’atto di fede e la fede in atto dell’azione liturgica, vuole primariamente «promuovere, aggiornare e qualificare lo studio e l’insegnamento della liturgia nelle facoltà teologiche, nei seminari e studentati religiosi o in altri istituti di scienze religiose, secondo lo spirito di SC 16 e di OT 16 e a norma della Ratio studiorum per i seminari», senza tuttavia tralasciare di «collaborare, nel suo specifico campo, alla promozione della vita liturgica nella Chiesa in Italia e favorire la formazione del clero in campo liturgico».
Perché si celebra
Un’attenta lettura diacronica degli Atti fa emergere, nella qualità dei contributi, l’attenzione posta ora più specificatamente a tematiche di fondo di liturgia sacramentale, di teologia liturgica fondativa; ora, più evidentemente, a tematiche di teologia pastorale liturgica con attenzione al contesto prevalentemente italiano ed europeo. Alla preoccupazione di approfondire il che cosa si celebra in Spirito Santo nella liturgia cristiana, nel trascorrere degli anni sempre più insistentemente si insinua la domanda del perché si celebra, domanda a cui si tenta di rispondere, di volta in volta, con l’attenzione a un metodo che coinvolga l’uso rispettoso delle cosiddette scienze umane. Anche gli altri contributi che assieme agli Atti costituiscono la collana “Studi di liturgia” (giunta al quarantottesimo volume, edita dalla Clv-Ed. Liturgiche, Roma) sono stati scelti, non solo per favorire le ricerche dei docenti o dei giovani studiosi di liturgia, ma anche per continuare a mantenere viva una problematica metodologica che permetta di approfondire il dato liturgico dal punto di vista storico, più propriamente teologico e antropologico, nel rispetto della realtà divino-umana che è la liturgia.
Con questa apertura, l’attenzione alle scelte proprie della pastorale liturgica, al come celebrare, rifugge da immediatezze contingenti, ma si preoccupa di offrire chiavi di lettura, prospettive che possono aiutare a far pensare i pastori, a liberarli dalla tentazione del “tutto o niente”, a confrontarsi con problematiche soggiacenti alle scelte pastorali, a volte disattese. Anche il manuale di liturgia Celebrare il mistero di Cristo (con i suoi tre volumi, di cui due pubblicati e il terzo in arrivo) e il sussidio Celebrare in Spirito e Verità (alla terza ristampa) sono strumenti programmati e realizzati per favorire personalmente le scelte pastorali a servizio del mistero celebrato e dei celebranti il mistero.
Di questa dinamica tra il teologico (studio-ricerca-insegnamento) e il pastorale sono garanti, se così si può dire al riguardo, i circa 270 soci, tra docenti e cultori, che seguono con interesse il cammino dell’ApI e vi partecipano, pur risentendo anche loro, globalmente, della crisi partecipativa odierna dell’associazionismo sia laico che religioso.
Molti di essi hanno avvertito e avvertono che attualmente, in un clima di complesse e composite e ambigue rimesse in questione della riforma conciliare e della sua attuazione, ad opera di persone e di gruppi pur ristretti, l’approfondimento che persegue l’associazione mira ad accogliere l’ethos della riforma per essere fedele allo spirito e alla lettera del concilio Vaticano Il, cosciente che lo spirito della liturgia e i linguaggi rituali propri della riforma conciliare coinvolgono, al di là dei limiti propri della condizione umana, un nuovo ethos di “sentire” la Chiesa e di viverla, di “sentire” il mistero e di viverlo, ben oltre il problema, assai isolato, di un’unica lingua che lo esprima, ben oltre una o l’altra orientazione del celebrante che presiede.
Nell’ottica del Vaticano Il
Lo stesso problema della partecipazione attiva, del canto-musica per la liturgia, delle dinamiche tra il sacro e il santo in sacramentaria, della ministerialità laicale, dell’inculturazione nelle Chiese di antica e nuova esperienza cristiana, dei problemi sollevati dal dialogo ecumenico, sono da leggere e da approfondire nell’ottica del rinnovamento avviato dal concilio Vaticano Il, con la continua attenzione alla parola di Dio attestata dalle Scritture e la consapevolezza di essere Chiesa in un’umanità culturalmènte variegata e in trasformazione, con rinnovata speranza e liberi da ogni paura, nel costante discernimento.
La riforma liturgica è da tempo decollata e la navigazione persegue una rotta nella fede e nella speranza, non timorosa delle turbolenze o rallentamenti o sobbalzi: nulla sarà più come prima, in una traditio dinamica, salva l’identità e l’assolutezza del dono della salvezza-redenzione che a noi si dona nelle dinamiche della incarnazione-risurrezione del Signore Gesù, nel suo Spirito Paraclito. La navigazione per l’Apl deve mirare a volare alto. Le settimane di studio annuali che si celebrano alternativamente tra il Nord, il Centro, il Sud e le Isole, e la sua Collana di studio, aperte a uomini e a donne che desiderano approfondire e confrontarsi, sono i suoi strumenti e mezzi privilegiati.
Il Notiziario Apl - Informazioni al suo 35° anno di vita con 83 numeri; il sito internet www.apl-italia.org, e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; l’efficace segreteria presso l’Abbazia di Santa Giustina, via G. Ferrari, 2A —35123 Padova, tel. 049.82.20.431, fax 049.82.20.469 (ccp 17506353); sono mezzi e strumenti al servizio di una esperienza ereditata dal Movimento liturgico italiano, che con tenacia persegue il suo scopo, e con una risonanza ormai internazionale.
e docente di teologia liturgico-sacramentaria
Bibliografia
Maggiani S., “Presentazione”, in Apl, Liturgia: itinerari di ricerca. Scienza liturgica e discipline teologiche in dialogo, Atti della XXV Settimana di studio ApI, 1996, Clv - Ed. Liturgiche 1997, Roma, pp. 5-12; Id., “L’opera ‘aperta’ dell’evento conciliare”, in Apl Informazioni 34 (2005) n. 83, pp. 5-10; Sartore D., “Associazione professori e cultori di liturgia”, in Sartore D. - Triacca A. M. - Cibien C. (a cura di) Liturgia, San Paolo 2001, Cinisello B., pp. 1379-1381; 1384-1385; Sodi M., “Il Decennale dell’Apl”, in Apl, Spirito Santo e Liturgia, Atti della XII Settimana di studio Apl 1983, Marietti 1984, Casale M., pp. 131-165.
29. I Sacramenti
Un settore essenziale della liturgia è la celebrazione dei sette sacramenti. Proprio in questo ambito la teologia negli ultimi decenni ha messo in luce nuovi aspetti e posto accenti nuovi.
L’anno liturgico celebra Cristo (Francesco Pio Tamburrino)
L’anno liturgico celebra Cristo
di Francesco Pio Tamburrino

L’anno liturgico si presenta come il calendario di Dio, che fissa gli appunta,menti decisivi per la vita dei fedeli e apre loro le ricchezze delle azioni salvifiche e dei meriti di Cristo Signore, così da renderli in qualche modo presenti in ogni tempo.
Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo, è lo stesso ieri, oggi e sempre (Eb 13,8)
Le espressioni di cui si è servita la tradizione per indicare l’anno liturgico sono tutte cariche di riferimenti teologici: “anno del Signore”; “anno della redenzione” (cf. Lc 4,19-21); “anno della grazia” (cf. Is 61, 1-2);”anno di salvezza”. In filigrana, il riferimento di fondo è al mistero di Cristo, centro della storia di salvezza, al quale si riannoda, mediante il memoriale, il nostro tempo consacrato dalle celebrazioni della liturgia. “Le tappe dell’”anno di grazia” riflettono i momenti decisivi della realizzazione della nostra salvezza in Gesù Cristo. Nel suo svolgimento l’anno liturgico ci fa seguire il dispiegamento di tutta la ricchezza del mistero di Cristo (1).
La prima e più Importante nota teologica dell’anno liturgico è il riferimento a Cristo Signore. “L’anno liturgico non è un’idea, ma è una persona, Gesù Cristo e il suo mistero attuato nel tempo e che oggi LA Chiesa celebra sacramentalmente come “memoria”, “presenza”, “profezia” (2).
1. Mistero di Cristo
Il riferimento allo sviluppo storico dell’anno liturgico è particolarmente indicativo per cogliere la teologia che soggiace ad esso. Le scansioni celebrative sono nate nell’antichità cristiana da un unico centro vitale: il mistero pasquale. Il culto della Chiesa è nato dalla Pasqua e per celebrare la Pasqua nel “dies dominicus”. All’inizio della liturgia cristiana l’unica festa era la domenica, memoriale ebdomadario del grande giorno della resurrezione. Ben presto, i legami delle comunità cristiane con l’ebraismo hanno fatto organizzare una celebrazione annuale del mistero pasquale, che resterà il punto culminante dell’anno liturgico, come del resto lo fu di tutta la missione di Cristo nella sua morte e resurrezione.
Un po’ alla volta, intorno a questo centro salvifico, sotto l’esigenza di “storicizzare” il mistero pasquale, le celebrazioni si sono dilatate in un “triduo pasquale”, nella settimana santa. Dando luogo ai battesimi nella grande Veglia Pasquale, e organizzando la disciplina penitenziale nei “quaranta giorni” che precedono la Pasqua, ne è nata la Quaresima come forte periodo preparatorio alla Pasqua. Così pure, l’esigenza di accompagnare i neofiti in un itinerario di approfondimento dei sacramenti ricevuti ha prodotto un ulteriore ampliamento nella celebrazione della cinquantina pasquale, che si conclude con la Pentecoste. Lo sviluppo delle celebrazioni è fortemente unificato da quell’unico centro focale, che è la Pasqua di Resurrezione.
Si può dire che la genesi dell’anno liturgico non avvenne principalmente sotto la spinta del pensiero teologico, che pure si andava sviluppando e organizzando nelle dispute contro le tendenze ereticali. Le celebrazioni nascevano dalla percezione della “eccedenza” del mistero di Cristo. La ricchezza inesauribile di tale mistero, compresa anche, nelle sue molteplici sfaccettature, alla luce della historia salutis e dei Vangeli ha determinato l’espansione del mistero di Cristo su spazi sempre più ampi.
L’anno liturgico celebra essenzialmente Cristo, non solo nei due cicli “cristologici” per eccellenza (Natale e Pasqua) e nel proprio del tempo dall’Avvento alla Pentecoste, ma anche nelle feste della Beata Vergine Maria e dei santi. Il “santorale” infatti celebra lo stesso evento salvifico di Cristo, in quanto ricevuto dalle membra di cristo, visto cioè nei suoi frutti, realizzato nelle sue membra più perfettamente configurate al Cristo morto e risorto (3).
Dopo una eccessiva proliferazione di feste dei Santi e delle devozioni particolari, che minacciavano di oscurare nella mente dei fedeli il punto centrale e primario, costituito dal mistero di Cristo, il Concilio Vaticano II, nel classico articolo 104 della Costituzione Liturgica Sacrosanctum Concilium afferma che la Chiesa celebra sempre e soltanto il mistero pasquale anche nelle feste dei suoi Santi, in quanto questi, più o meno perfettamente sono configurati al mistero di Cristo morto e risorto, e come tali sono celebrati e presentati come modelli alla Chiesa.
2. Crescita in Cristo
L’anno liturgico è cristocentrico anche in forza dei sacramenti che si celebrano perché gli uomini possano essere associati alla salvezza operata da Cristo. “Moritur Christus ut fiat Ecclesia: muore Cristo perché nasca la Chiesa” (4): la Chiesa nasce dal mistero pasquale di Cristo comunicato nei sacramenti. In tal modo Cristo ci raggiunge e ci convoca nel suo mistero pasquale. I sacramenti, che riuniscono tutti i diversi aspetti del mistero, con la meravigliosa semplicità di un solo segno ricco di una straordinaria pienezza, ci permettono di accogliere, per mezzo di “ritus et praeces” i gesti che Cristo ha compiuto “per noi uomini e per la nostra salvezza”.
“L’anno liturgico è la vicenda di Cristo che si inserisce sul piano personale per diventare salvezza, non isolando la persona, ma immettendola nel dinamismo della “istoria salutis” (5)”. In esso infatti “mysteria redemptionis… (Ecclesia) fidelibus aperit, adeo ut omni tempore quodammodo praesentia reddantur: ricordando i misteri della redenzione, la Chiesa aopre ai fedeli le ricchezze delle azioni salvifiche, in modo tale da renderli come presenti a tutti i tempi” (Sacrosanctum Concilium, 102).
Nella liturgia cristiana, nessuna celebrazione è identica all’altra. L’anno liturgico è un andare avanti, a partire dal punto in cui si era arrivati, è un nuovo avvento di Cristo nella vita della Chiesa e di ciascuno. Di festa in festa siamo “sempre di nuovo” davanti a Dio in Cristo, per realizzare il “crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e testimoniarlo con una degna condotta di vita” (Colletta della I dom. di Quaresima).
O. Casel paragona l’anno liturgico alla salita di una montagna attraverso tornanti che si affacciano sugli stessi versanti, ma a quote differenti: “Come una strada corre serpeggiando intorno ad un monte, allo scopo di poter raggiungere a poco a poco, in graduale salita, la ripida vetta, così noi dobbiamo ogni anno ripercorrere su un piano più elevato la stessa via, finché non sia raggiunto il punto finale, Cristo stesso, nostra meta”.
Si tratta insomma di “vivere questa vita di Cristo Signore, questo cammino imponente, dal seno della Vergine fino al trono della divina maestà nell’alto dei cieli, questo mistero. Si tratta di celebrare e di fare nostre grandi realtà della salvezza, non semplicemente di contemplare e imitare nel sentimento la vita terrena del Signore, nei suoi particolari.
Questo potrebbe farlo anche un non battezzato, mentre noi cristiani e cattolici siamo chiamati a celebrare il mistero di Cristo, servendoci della potenza che ci viene dallo Spirito di Dio; non ricevendo soltanto illuminazioni e grazie, ma partecipando all’oggettiva spirituale realtà di Cristo presente… Soltanto così possiamo attingere, pieni di gioia, dalla sorgente di vita che è Cristo Salvatore… L’affermazione di Cristo: Io sono la via si realizza così nel modo più elevato. Cristo non è semplicemente l’esempio e tanto meno uno che indichi la via: è invece la via vera e propria, che ci porta fino alla meta” (6). L’anno liturgico non ricalca la concezione statica, greco-romana, del tempo, chiuso nella ripetitiva ciclicità di mesi, stagioni e anni; deriva invece da quella biblica, che concepisce il succedersi del tempo come una spirale progressiva, diretta verso il compimento finale della salvezza.
“L’articolazione del ciclo liturgico non deve trarre in inganno. Le varie fasi (Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua) si giustificano come diversi approcci dell’unico mistero, e si caratterizzano per il riferimento alle sue fasi.
Procedimento pienamente legittimo e altamente pedagogici, purché si tenga ben presente che il mistero è uno solo: Cristo pasquale. E allora, quando celebro l’Avvento, non dimentico che egli è già venuto; quando celebro la Quaresima non mi sento come uno che attende ancora la purificazione dal sangue di Cristo, ma come un credente che porta già il sigillo della croce e vuole solo immedesimarsi meglio con essa… Ogni fase va collegata con il paschale sacramentum.
Così il Natale non è solo la celebrazione della nascita di Cristo: è il mistero della redenzione, vista in una determinata angolazione: il Verbo che si fa carne per salvarci (7).
3. Storia della salvezza in atto
La concentrazione cristologica del mistero celebrato nella liturgia va intesa secondo la legge intrinseca della economia di salvezza contenuta nelle Scritture e che ha raggiunto la sua pienezza in Cristo. Dalla creazione all’Apocalisse Dio entra nella storia degli uomini con un piano organico e progressivo, in cui “con eventi e parole intimamente connessi tra di loro” (Dei Verbum, 2), Dio attua la salvezza ponendovi Cristo Signore quale centro verso cui tutto converge e da cui tutto si irradia.”L’anno liturgico celebra il mistero di Dio in Cristo, quindi è radicato su quella serie di eventi mediante i quali Dio è entrato nella storia e nella vita dell’uomo” (8). La liturgia celebra tutta la storia della salvezza incentrata nella persona e nei fatti della vita storica di Gesù . il prima di Cristo è la storia sacra dell’Antico Testamento, colta nella sua dimensione essenzialmente profetica; il dopo di Cristo è il tempo della Chiesa, che ha per pietra angolare Cristo Gesù e per fondamento gli apostoli e i profeti della Nuova Alleanza.
Questa triplice dimensione storica è resa presente nella liturgia dall’annuncio degli avvenimento dell’Antico Testamento, del Vangelo e degli scritti apostolici. L’esempio più luminoso è presentato dalla successione delle letture della Veglia pasquale; ma anche le grandi formule di benedizione (dell’acqua, degli oli), di ordinazione,di dedicazione del tempio e dell’altare, le preghiere di “raccomandazione dell’anima”, seguono lo stesso modulo.
Il modo proprio con cui la liturgia permette di rivivere oggi gli eventi salvifici annunciati e commemorati nella celebrazione è il memoriale.
E’ vero che l’anno liturgico ha una sua funzione didascalica, utile per la catechesi, e nei contenuti offre l’essenziale per un itinerario di fede e di evangelizzazione. Tuttavia va tenuto presente che l’anno liturgico non è un album di cartelloni per la catechesi, ma la persona di Cristo: esso ci permette di entrare in contatto con i suoi misteri, che sono vivi e operanti nella liturgia.
Nel memoriale le azioni salvifiche di Cristo sono rese ritualmente contemporanee e attualizzate. L’avvenimento salvifico del passato non si ripete, ma si fa presente ed efficace qui-ora-per noi. “Ciò che era visibile del nostro redentore – afferma San Leone Magno – è passato nei riti sacramentali” (Discorso II sull’Ascensione, 1,4).
Se la festa della Chiesa è Cristo, celebrare significa partecipare alla sua grazia che ci salva. La categoria della “partecipazione” non deve essere banalizzata, limitandola – come spesso si è fatto nel periodo post- conciliare – al coinvolgimento dell’assemblea nei canti, nelle preghiere e nei ministeri, tirandola fuori dal mutismo e dalla passività in cui si era rifugiata per secoli. Partecipare è accogliere la presenza del Risorto, legarsi a lui e vivere con lui; è diventare parte di Cristo, divenendo suo pleroma, con la Chiesa e come la Chiesa. Cristo ci prende dentro i suoi misteri; mediante lo Spirito Santo li innesta nella nostra vita e li fa vivere in noi.
4. Riscatto del tempo
Nella liturgia convergono, come eredità della visione biblica, tre livelli del tempo: quello regolato dai cicli della natura (tempo cosmico); quello che si svolge nel fluire degli avvenimenti (tempo storico); l’uno e l’altro Dio li governa e li orienta verso un fine (tempo salvifico).
Nell’anno liturgico i cicli stagionali, la successione dei mesi, delle settimane e dei giorni, la sera e il mattino, la notte e il giorno, il tempo della vita terrena pieno di esperienze umane e luogo del divenire di tutte le cose, insomma il chronos assume una qualifica salvifica, mediante il kairòs: spazio e tempo propizio per la salvezza, abitato dal mistero di morte-resurrezione di Cristo.
Il tempo astronomico (chronos) misura in modo inarrestabile il nostro divenire e la nostra decadenza fisica. Dio riscatta la vita umana, facendole superare la prigione del proprio limite esistenziale, introducendola nella “pienezza del tempo” (Ef 1,10). “La realizzazione del mistero di Cristo ha inaugurato un’era nuova, cioè dei tempi che non sono più assoggettati alla vanità, alla decomposizione, ma riempiti ormai dell’azione dello Spirito in vista del ristabilimento di tutte le cose.
In Cristo ci è donato di vivere un tempo reale, non vuoto ma pieno, non fuggevole ma compiuto (K. Barth). Perché in lui il passato non si deposita in un pur ricorso, non si allontana, ma ci accompagna come una realtà viva; in lui il presente non si perde continuamente nella fretta della vita, non è subito sorpassato, ma si trova già, in maniera del compimento finale, della gloria a venire” (9).
Dio ha già operato la redenzione del tempo, con tutti i gesti di salvezza che ha compiuto dalla creazione fino ad oggi, da Abramo a Mosè, a Davide, ai profeti, fino alla pienezza dei tempi, in cui il Figlio eterno si è fatto uomo nel tempo e nello spazio e ha riempito di amore e di salvezza la vita degli uomini. Cristo Gesù è il punto di interferenza e di approdo nella storia del “tempo divino”.
La liturgia cristiana è l’ultima tappa della storia della salvezza, in continuità con ciò che Dio ha compiuto “in illo tempore”, e insieme aperta verso la realizzazione finale nel mistero che celebra.
L’anno liturgico è la continuazione della storia della salvezza. Il passato è costellato dai grandi interventi divini. Questi “magnalia”, nel tempo presente, sono i sacramenti. Senza clamore, sotto il velo dei segni, sono interventi meravigliosi di grazia che si svolgono sul nostro cammino.
ConclusioneNella teologia dell’anno liturgico c’è la risposta al più angoscioso interrogativo dell’esistenza umana: la vita umana nel tempo non è una corsa insensata verso il nulla. La storia è lo spazio in cui Dio si affianca all’uomo e cammina con lui: luogo d’incontro e di amore, svelamento della filantropia divina, che si compromette fino a dare un nuovo senso s tutti gli interrogativi della vita: dal nascere al morire, dalle gioie alla sofferenza. La piccola storia, il frammento in cui si trova a vivere ogni uomo è un calice che attende di riempirsi in Cristo. La “virus” che usciva da Cristo deve poter raggiungere l’uomo, toccarlo (Lc 6,19) per guarirlo.
Il primato di Cristo, nell’anno liturgico, è primato di Dio nell’opera della salvezza. Egli è “il solo che opera meraviglie, perché eterna è la sua misericordia” (Sal 135,4). Il protagonista principale della liturgia non è né il ministro, né l’assemblea dei fedeli. Nella liturgia noi “movemur: siamo mossi” dallo Spirito (Rm 8,14). E’ lo Spirito che ci prende per mano, ci conduce verso il “Padre santo fonte di ogni santità” e ci introduce, mediante l’epiclesi, nella “grazia di Dio, che è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore” (Rm 6,23) (10).
Note
1) F. STOOP, L'an del grâce, in AA.VV., Les étapes de l’an de grâce, Neuchâtel 1962, p. 7.
2) A. BERGAMINI, Anno liturgico, in D. SARTORE – A.M. TRIACCA, Nuovo Dizionario di liturgia, Roma 1984, p. 65.
3) Cf. P. VISENTIN, La celebrazione del mistero pasquale nella memoria della Vergine e dei Santi, in ID., Culmen et fons, I, Padova 1987, pp. 340-344.
4) S. AGOSTINO, Tract. in Io 9,10.
5) M. MAGRASSI, Cristo luce sul nostro cammino, in Liturgia 12 (1978) p. 781.
6) O. CASEL, Il mistero del culto cristiano, tr. it., Torino 1959, pp. 113-114.
7) M. MAGRASSI, Cristo luce sul nostro cammino, cit., p. 783.
8) A. BERGAMINI, Anno Liturgico, cit., p. 67.
9) F. STOOP, L’an de grâce, cit. p. 22.
10) A. M. TRIACCA, Anno liturgico: «icona del rapporto tra “hodie” e l’”escaton”», in Rivista Liturgica 75 (1988) p. 479.
10. I bilanci della riforma nei documenti ufficiali (Riccardo Barile)
A vent'anni dal concilio si celebrò un sinodo straordinario dei vescovi (1985). Il passo che riguarda il bilancio liturgico constata che il rinnovamento «è stato accolto con gioia e con frutto dai fedeli», ma sottolinea che ora bisogna puntare alla «partecipazione interiore e spirituale».
28. Le devozioni
Sarebbe una perdita dimenticare quelle devozioni che la pietà popolare ha reso tradizionali. In esse, se celebrate con giusto spirito, si trova la ricchezza della preghiera.
9. Inculturazione della liturgia o liturgia inculturata? (Samuele Riva)
La domanda può apparire una tautologia. In realtà sottende una questione non irrilevante: la liturgia del Vaticano II è deducibile da principi astratti e si attua in una forma rituale-rubricale 'aggiornata' da esperti del settore (cosa che chiamiamo inculturazione della liturgia)
27. La preghiera personale
Non è possibile definire l’uomo senza ricorrere alla comprensione della preghiera. Ma egualmente non possiamo comprendere la vera natura e lo scopo della preghiera senza comprendere la vocazione totale dell’uomo. Chi è l’uomo che prega?
8. La nobile semplicità e la partecipazione attiva (Gianni Cavagnoli)
La formulazione di SC 34 rappresenta davvero un piccolo gioiello, in quanto evidenzia come si possono affermare solidi principi in maniera chiara e con sobrietà di dettato:
La liturgia delle ore
La liturgia come azione comune di Cristo e della chiesa si realizza anche nel quotidiano servizio di preghiera della Chiesa, la liturgia delle ore.