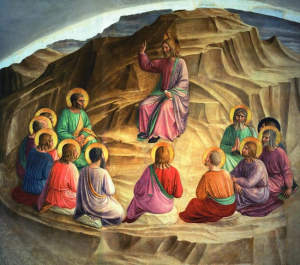La vita di s. Benedetto, dataci da s. Gregario Magno, ha un carattere mistagogico. Sembra ormai tramontato il genere mistagogico propriamente detto, com’era presso Leone Magno, Ambrogio, Cirillo, ecc., forse anche per gli sviluppi nuovi assunti dalla disciplina dei sacramenti dell’iniziazione cristiana. La mistagogia troverà un campo, forse più proprio che nei tempi precedenti, nel genere agiografico, in cui Bibbia e liturgia trovano la loro immediata espressione vitale ed esistenziale. La pietà popolare, che era sempre più l’ambito normale e più consono alla presenza degli stessi grandi vescovi, esigeva una risposta di fede sempre più «visiva», alla portata della semplicità di fede dell’uditorio di quel travagliato sesto secolo. La vita monastica, così legata alla tradizione popolare, troverà nella descrizione delle vite dei santi il genere più qualificato per edificare nella fede le varie comunità. Lo stesso commentario biblico si risolverà nel leggendario dei santi. Sono essi, i santi, i modelli in cui rivivono le gesta dei patriarchi, dei profeti, degli apostoli, ma soprattutto di Gesù. Se per un verso questo sforzo apre la vita a una forte «moralizzazione» della storia della salvezza, c’è peraltro da affermare che l’agiografia quando trovava un padre illuminato, come ad esempio s. Gregario Magno, poteva veramente essere la risposta più esauriente e più concreta di quanto la Parola di Dio esigeva nel suo «oggi» esistenziale. La “Leggenda dei santi” previene in certo modo lo sforzo odierno dell’ermeneutica sul rapporto della Bibbia con la storia e il vissuto quotidiano condotto e letto alla luce della Parola di Dio. L’agiografia insomma si poneva come “genere letterario” che ripresentava con movimento quasi autonomo, quel “senso spirituale” della santa scrittura così fondamentale per l’esegesi dei Padri.
Seguiamo la narrazione che Gregorio Magno ci fa del transito di s. Benedetto. Sembra importante la constatazione che s. Gregorio, quando parla della morte degli “uomini di Dio”, usi normalmente il termine “exitus” o “transitus”.
«Sei giorni avanti la sua morte si fa aprire il sepolcro. Subito assalito da febbre, cominciò ad essere tormentato da ardentissimo calore. Poiché di giorno in giorno s’era aggravato lo sfinimento, il sesto giorno si fece trasportare dai discepoli nell’oratorio, ed ivi, dopo essersi fortificato per il suo transito ricevendo il corpo e il sangue del Signore, sostenute le deboli membra tra le braccia dei discepoli, in piedi, le mani levate al cielo, nella preghiera, esalò l’ultimo respiro».
A due fratelli che non avevano potuto assistere al transito di Benedetto apparve la manifestazione di una visione:
«Videro una via tappezzata di drappi e splendente d’innumerevoli luci. Una voce di personaggio misterioso che diceva: Questa è la via per la quale Benedetto, l’amico di Dio, è salito al cielo».
Per ben comprendere “l’ascensione di Benedetto al cielo”, bisogna notare qual è l’iter spirituale che egli percorre. Notiamo i vari aspetti.
A) L’ESODO DI BENEDETTO DAL MONDO
La narrazione del transito di s. Benedetto si pone come epilogo della vita dell’uomo di Dio che inizia con una «uscita» – egressus – dal mondo per piacere totalmente a Dio. Anche Benedetto come Abramo, lascia tutto per obbedire alla voce di Dio. È importante notare che tutto il prologo del libro II dei dialoghi è ritmato da una logica di “transitus”; lo stesso “Cursus” del periodo:
«Aetatem quippe moribus transiens...dispexit iam quasi aridum mundum cum flore...retraxit pedem...Despectis itaque litterarum studiis, relicta domo...soli Deo piacere desiderans sanctae conversationis habitum quaesivit».
L’esperienza dell’abitazione nello speco sublacense è come il coronamento di questo «esodo» di Benedetto dal mondo. Ma Gregorio Magno è profondamente conscio dell’ambiguità spirituale contenuta in questo «exodus» di Benedetto dal mondo quando interiorizza fin dall’inizio della “vita Benedicti” l’esperienza di deserto del suo eroe nella formula «habitavit secum». Ormai il deserto nella sua fisicità è posposto al deserto interiorizzato, a vantaggio di un servizio ecclesiale bene qualificato. Ed è il primo quesito del libro II dei Dialoghi.
«Pertanto il venerabile Benedetto – spiega Gregorio – in quella solitudine abitò con se stesso, perché tenne in custodia se stesso nella clausura del pensiero; mentre ogni volta che l’ardore della contemplazione lo rapì in alto, lasciò se stesso al di sotto di sé» (L.III,c.III).
Ogni vita monastica che volesse presentarsi come una «fuga mundi» in senso esclusivo è così posta fuori discussione.
B) LA PROSPETTIVA PASQUALE DELL’ESODO
Questo movimento della contemplazione e della carità perfetta porta l’uomo di Dio «sopra di sé». La cena è la prima espressione vitale nella gioia della pasqua che porta fuori dallo speco sublacense Benedetto e lo colloca quale lampada luminosa sul candelabro per illuminare quanti sono nella casa del Signore. Per pasqua, un prete porta l’annuncio dell’alleluia a Benedetto che viveva fuori del mondo; è questa la prima grande nota mistagogica della «vita Benedicti». «Oggi è pasqua, non conviene che tu digiuni!». Da quel momento Benedetto esplica il suo carisma di padre spirituale dei monaci (L. II. c. I). Come la chiesa inizia il suo cammino lungo la storia nella pasqua, così ogni ulteriore espressione di fede dovrà misurarsi con l’esperienza della morte e risurrezione del Signore e col dono dello Spirito. L’esodo iniziale di Benedetto conosce così l’ingresso nella terra promessa, sia pure nel cammino di fede di cui è segno la comunità ecclesiale.
A questo evento ecclesiale di Benedetto, segnato dalla pasqua, che lo fa maestro di monaci, segue una profonda esperienza che noi potremmo chiamare mistica, che Benedetto percepisce poco tempo prima del ritorno definitivo al Padre con la morte. Anche questa esperienza mistica di Benedetto, che si pone come pagina di una altissima intuizione di fede, nella letteratura cristiana di tutti i tempi, verte sulla pasqua come sintesi universale e cosmica, qual è vissuta dal cristiano nella pienezza della fede.
«Benedetto prevenendo il tempo della preghiera notturna, pregava il Signore onnipotente stando in piedi alla finestra; d’improvviso, in quell’ora inconsueta della notte, vide una luce diffondersi dall’alto, fugare per ogni dove l’oscurità notturna e divampare in uno splendore così grande, da vincere la luce stessa del giorno. In questa visione successe una cosa mirabile: tutto intero il mondo fu portato dinanzi ai suoi occhi come raccolto in un unico raggio di sole. In quella luce Benedetto vide l’anima di Germano, vescovo di Capua trasportata in cielo dagli angeli dentro un globo di fuoco».
Nella spiegazione di questa visione, Gregorio fa emergere il riflesso pasquale a livello esistenziale:
«...Rapito nella luce di Dio al di sopra dei propri limiti, l’anima ne è dilatata al di sotto di sé; comprende quanto angusto sia tutto quanto la sua natura terrena non poteva comprendere... Che meraviglia, dunque, che abbia veduto raccolto dinanzi a sé il mondo, poiché sollevato nella luce dell’anima, era fuori dal mondo?».
Che il fenomeno poi sia da ricondursi alla pasqua del Signore lo dimostra il fatto che Benedetto in quella luce «vide l’anima di Germano vescovo, trasportata dagli angeli dentro un globo di fuoco» (L. II e. 35).
C) IL RITORNO AL PADRE DI S. BENEDETTO
Il transito di Benedetto giunge così come un epilogo di questa memoranda storia della salvezza vissuta spiritualmente dall’uomo di Dio, Benedetto. Credo che il genere mistagogico – senso spirituale – si rifletta in tutta la narrazione gregoriana. Il richiamo ai «sei giorni avanti la sua morte» quando Benedetto si fa aprire il sepolcro, ripropone la settimana biblica, in cui il sesto giorno fu creato l’uomo in vista del riposo sabbatico. Ma quel «sesto giorno», conduce ancor più alla morte del Signore e alla sua risurrezione. Benedetto è solidale con il suo Signore perché il sesto giorno si fece trasportare dai discepoli nell’oratorio ed ivi, dopo essersi fortificato per il suo transito ricevendo il corpo e il sangue del Signore, sostenuto dai fratelli, in piedi, le mani levate al cielo, tra le parole della preghiera, esalò l’ultimo respiro. Il richiamo al sacramento del corpo e del sangue del Signore e a Benedetto che, sostenuto dai fratelli – in piedi – ritorna al Padre, pone l’attenzione nostra sull’eucaristia come sacramento pasquale per eccellenza e la comunione fraterna come garanzia che deritualizza – se ce ne fosse bisogno – il sacramento del corpo e del sangue del Signore. La voce misteriosa poi che giunge ai due discepoli lontani, assicura che Benedetto, come Gesù, è asceso anch’egli al cielo : «Questa è la via per la quale Benedetto, l’amico di Dio, è salito al cielo».
Non vorremmo passare sotto silenzio un altro particolare di fede pasquale, che si manifesta nel «transitus» di Benedetto. Un miracolo dopo la morte di Benedetto viene operato nello «speco» ove l’uomo di Dio aveva fatto la sua prima esperienza monastica – era perciò solo spiritualmente presente – e non invece al sepolcro che custodiva il suo corpo. La spiegazione di Gregorio coincide con la beatitudine di Gesù a Tommaso: beati piuttosto quelli che credono senza vedere. E poi la presenza dello Spirito è data ai fedeli con l’ascensione di Gesù al Padre!
La vita di Benedetto dall’«esodo» iniziale, alla quaresima trascorsa nello speco; dalla pasqua quando egli riceve la missione di essere il padre dei monaci, all’esperienza mistica della pasqua come momento unificante della storia – vive l’epilogo nel suo esodo finale, la morte, salutata come «ascensione» al Padre con Gesù Signore.
Siamo sempre più convinti che la narrazione gregoriana della «vita Benedicti» vada al di là di ogni dimensione storicistica e che essa si pone come una pagina viva di storia della salvezza vissuta dall’uomo di Dio, Benedetto.
GLORIA A DIO!
(Benedetto Calati)